Il 26 gennaio 2020 ho mandato un’email alla sociologa tecnofemminista Judy Wajcman chiedendole se potevamo incontrarci per un’intervista riguardo al suo libro La tirannia del tempo allora di imminente uscita in Italia per Treccani. Wajcman ha risposto poche ore dopo rendendosi disponibile ma informandomi che l’indomani sarebbe partita per l’Australia, che sarebbe rientrata a Londra il 10 Marzo e che quindi avremmo potuto alternativamente fare una videoconferenza. Avremmo potuto, perché prima la situazione in Australia, reduce dagli incendi drammatici degli ultimi mesi, richiese tutto il suo tempo, poi l’emergenza COVID-19 richiese il mio (e immagino anche il suo).
Racconto questo episodio perché mi pare che contenga due coincidenze che illuminano alcune delle tesi sostenute da Wajcman nel suo libro. Se nella storia di una video-intervista mancata si trova, seppur banalmente, tanto l’idea delle tecnologia come infrastruttura che permette di superare limiti di spazio e tempo quanto il rifiuto del determinismo tecnologico.
L’uso del tempo si differenzia in base ai diversi gruppi sociali
Dall’altro, nell’emergenza che stiamo vivendo nell’ultimo mese, prende invece forma tangibile la questione principale discussa da Wajcman secondo cui non è la tecnologia a definire il nostro rapporto con il tempo e gli altri, ma le pratiche sociali.
Sebbene il libro sia stato pubblicato originariamente nel 2015 in seguito a una serie di studi condotti negli anni precedenti, l’assunto di base di Wajcman si fa particolarmente rilevante in questi giorni: il tempo che una persona ha a disposizione e il modo con cui lo investe possono essere compresi soltanto come il risultato di determinati modelli sociali ed economici.
L’uso del tempo, in altre parole, si differenzia in base ai diversi gruppi sociali e la pressione che questo esercita più che un fenomeno individuale è correlato ai mutamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni, tra cui, ad esempio, la composizione dei nuclei familiari, i rapporti di genere, o la mercificazione sempre più accentuata del tempo stesso.
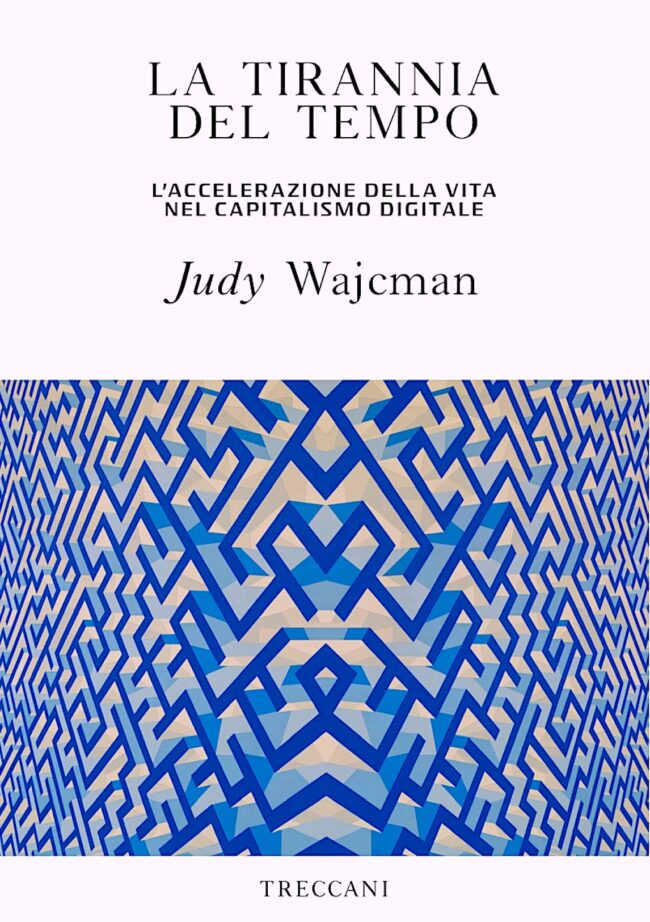
Prendiamo alcuni esempi. Partiamo da uno banale: la lavatrice ha effettivamente ridotto il tempo richiesto a una persona per lavare i propri capi, eppure le aspettative di igiene sono aumentate, di conseguenza il numero di lavaggi necessari per soddisfarle sono aumentati portando a un bilancio del tempo impiegato praticamente immutato.
O uno più articolato: con lo smart working è possibile una gestione del tempo e dello spazio flessibile, ma il tempo richiesto per prendere una decisione unanime quando si lavora in maniera asincrona può allungarsi considerevolmente richiedendo quindi l’organizzazione di incontri online la cui pianificazione richiede spesso un notevole dispendio di tempo.
Oppure, cambiando ancora contesto di riferimento, le email hanno ridotto il tempo di comunicazione, ma la necessità di rispondere in tempi sempre più brevi non è intrinseca alla tecnologia quanto alla pratica di associare un valore positivo alla velocità che deriva dalla mercificazione del tempo che si è realizzata col passaggio al moderno capitalismo industriale e che domina oggi in maniera preponderante la gig economy. Gli esempi potrebbero essere infiniti, quel che conta è evidenziare come accelerazione e velocità non siano connaturate alle nuove tecnologie, ma dipendono dal modo in cui le usiamo.
Partendo da Marx e passando per la dromologia di Virilio, Wajcman presenta una serie di case studies e indagini da lei effettuate negli anni precedenti la pubblicazione del libro per decostruire la percezione ormai comune che le tecnologie e in particolare le ICT (information and communication techonologies) ci rubino sempre più il tempo. Gli studi presentati spaziano dall’ambito lavorativo a quello privato e si interrogano, portando dati scientifici a supporto delle risposte, su come e se le tecnologie abbiano davvero influenzato il nostro uso del tempo.
Tra i campi di osservazione ci sono ad esempio lo studio della disposizione dei posti di lavoro negli uffici e lo smart working
Tra i campi di osservazione ci sono ad esempio lo studio della disposizione dei posti di lavoro negli uffici e lo smart working, l’impatto degli elettrodomestici sull’organizzazione della vita domestica e la condivisione del tempo per la gestione familiare, l’aumento della velocità dei mezzi di trasporto, ma anche il ruolo degli smartphones nella tenuta dei legami d’affetto.
Quella di Wajcman è insomma un’indagine a largo spettro della nostra quotidianità volta a dimostrare come le ICT non intacchino direttamente il tempo privato, ma lo riconfigurino rendendo più porosi i confini tra lavoro e tempo libero. Di questa aumentata porosità, se fossimo una società in cui il tempo di ciascuno ha lo stesso valore, ci si dovrebbe avvantaggiare perché garantirebbe maggiore flessibilità organizzativa, ma in una dove status e retribuzione misurano il valore del tempo genera e inasprisce le disuguaglianze sociali portando alla demonizzazione di chi ha tempo e il culto dell’impegno.
Similmente le tecnologie digitali, lungi dal portare a un maggiore distanziamento sociale, renderebbero possibili nuovi modi di declinare la prossimità emotiva, meno vincolanti a un tempo e uno spazio condivisi. Il che, mi pare, sia quanto più evidente durante questa emergenza dove all’isolamento siamo costretti dalle circostanze e l’incontro avviene proprio grazie alle tecnologie digitali.
Lontana dal riconoscere alla tecnologia il ruolo unico di panacea, Wajcman la mette dunque in rapporto dialettico con la società che l’ha sviluppata, sottolineando tanto il suo valore emancipatorio quanto quello di amplificatrice delle disuguaglianze sociali.
Nel far ciò allinea la sua posizione tecnofemminista a quella ecofemminista di Donna Haraway, secondo cui “non è questione di arrendersi o di opporsi alla tecnoscienza, bensì di gestirla in modo strategico senza mai perdere lo sguardo spietatamente critico”.
Wajcman allinea la sua posizione tecnofemminista a quella ecofemminista di Donna Haraway
Mai come oggi le tecnologie intelligenti e veloci danno l’opportunità di costruire una società più umana e più giusta, dice Wajcman, ma è essenziale rendersi conto che la nostra sensazione di affanno non dipende da un repertorio di dispositivi, bensì da priorità e parametri che noi stessi ci siamo imposti. Se le tecnologie non sono riuscite a portare il cambiamento sperato, come una più equa distribuzione del lavoro e valorizzazione del tempo, non è che la concreta espressione dei limite e della stasi che tutt’oggi caratterizzano le nostre aspirazioni collettive, in ambito sia sociale sia politico.
È giunto dunque il momento di contestare l’euforia per la velocità (e l’afflato tecnologico a ottenerla), e di imbrigliare la nostra creatività per progettare nuove tecnologie che ci permettano di prendere il controllo del nostro tempo, per la maggior parte del tempo possibile, perché sono queste a rispecchiare i contorni della nostra immaginazione e non il contrario.
L’intervista che non ho mai fatto a Wajcman si apriva con una domanda: quando ho iniziato a leggere La tirannia del tempo speravo di trovare una nuova prospettiva sostenuta da ricerca ed evidenza statistica che mi permettesse di decostruire e comprendere la sensazione costante di mancanza di tempo che vivo in una società che mi pare (pareva) sempre più accelerata.
Giunta alla fine, per quanto comprendessi lo scenario futuro e la direzione di riflessione che suggerisce di intraprendere per rivalutare questo rapporto, ho provato un senso di frustrazione perché mi pare che per poter davvero ripensare questo rapporto sia necessario un cambio sistemico.
Mi chiedo che senso avrebbe questa domanda oggi, a soli tre mesi da quando l’ho pensata. Mi chiedo che effetto mi farebbe oggi leggere La tirannia del tempo. Se non lo troverei ancor più attuale o, al contrario, superato. Che effetto mi farebbe pensare alla tecnologia da un punto di vista socio-materiale pensando a tutti gli studenti che stanno seguendo le loro lezioni dagli schermi dei computer di casa, ai lavoratori precari di Uber, Deliveroo, e via dicendo che oggi si trovano con le app spente e senza un’entrata, a quei lavoratori invisibili – spazzini, commesse, infermiere – che oggi sono in prima linea per garantire i servizi minimi e vitali della nostra società improvvisamente paralizzata.
Mi chiedo insomma se non sia proprio questo il momento di ripensare le pratiche sociali basate sull’uso della tecnologia e se ripartire non significhi anche creare delle opportunità per riprenderne possesso, migliorarle e, nei limiti del possibile, renderle più eque. Forse avrei dovuto chiederglielo di persona, magari attraverso una Skype call, ma ora come non mai sento il bisogno di prendere tempo, di pormi domande prima ancora di cercare risposte.
Immagine di copertina: particolare dalla copertina del libro, La tirannia del tempo, Treccani libri


