Una volta i videogiochi erano lenti. Giocando si doveva rispettare i ritmi delle macchine e la loro capacità di elaborazione; certe volte persino sottomettersi a quei tempi. Oggi piattaforme di videogiochi come Steam sono in grado di supportare 26 milioni di utenti che giocano nello stesso momento mentre videogiochi come Fortnite e Warzone uniscono milioni di giocatori da tutto il mondo e di tutte le età, in campi di battaglia sconfinati caratterizzati da ritmi forsennati e astute tattiche di guerra. In generale è un settore che nel 2021 ha generato circa 175 miliardi e che sembra espandersi con le sue logiche verso uno sconfinamento e una ibridazione con le sfere del lavoro, della comunicazione e della politica. Così mentre la gamification introduce azioni tipiche del gioco all’interno di contesti lavorativi e sociali, il play-to-earn capovolge il concetto di gioco, pagando i migliori giocatori e compensando le singole attività di gaming che prima erano gratuite, attivando cioè delle vere e proprie realtà economiche all’interno di spazi che un tempo avevano “solo” una dimensione ludica. Dare un nome, un luogo e un prezzo a questo insieme di dissipazioni di energia (direbbe Bataille) che agiscono come una forza lavoro senza un preciso compito (macchine desideranti direbbero invece Deleuze e Guattari) è la principale contraddizione su cui poggiano le intelaiature dei “nuovi” metaversi.
Forse è proprio partendo da questo senso dell’azione o presunta azione, che può ancora aiutarci leggere un libro pubblicato per la prima volta nel 2006 come – Gaming. Saggi sulla cultura algoritmica (Numerus)- di Alexander R.Galloway .
La sensazione che si ha quando Galloway analizza esperienze di gioco come quella del modello dei videogiochi strategici a turni di Civilization in cui si costruiscono degli imperi partendo dal grado zero della civiltà, oppure quando si sofferma sulla raffinatezza e il romanticismo degli enigmi di Myst in cui una architettura labirintica costringe i giocatori a perdersi e a godere masochisticamente della fascinazione dell’ambiente da cui non riescono ad uscire, è quella di un profondo cambiamento delle azioni che si attivano durante un videogioco.
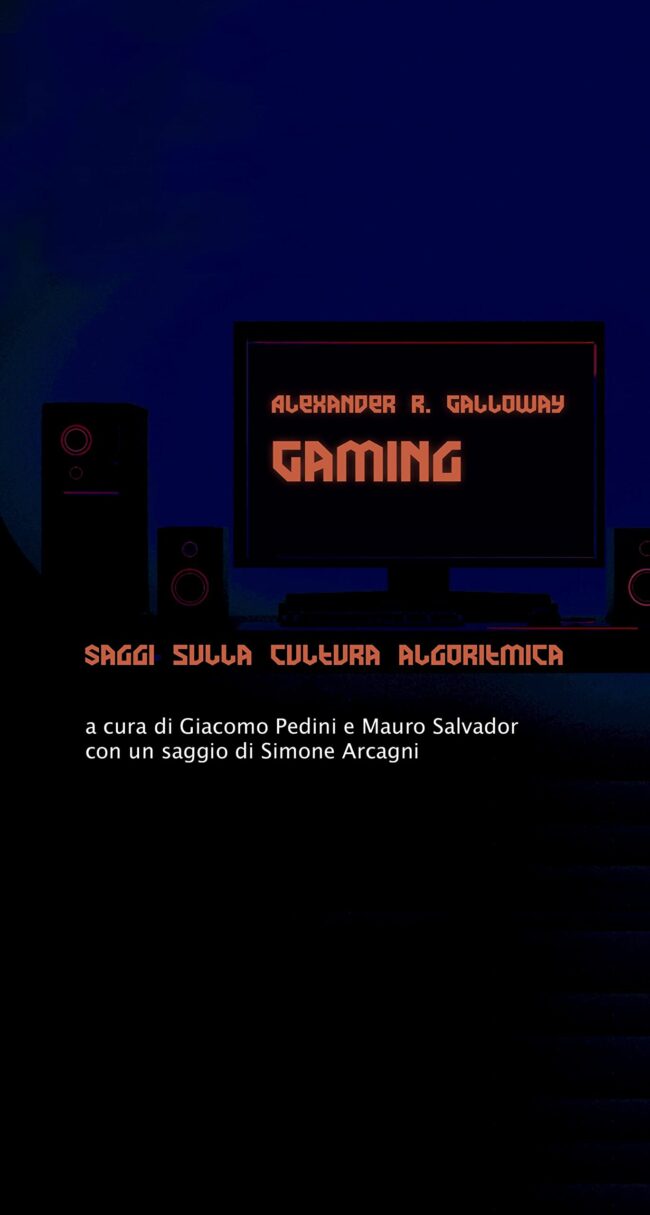
In questo saggio, Gallowey chiama quell’errare raminghi per mondi aperti e in costruzione “poesia dell’algoritmo” (pag. 41) e scompone e ricompone le figure retoriche, le immagini e le forme che contribuiscono a questa creazione.
Il lavoro di Galloway, quindi, sembra più che altro intenzionato a capire quanto i videogiochi riescano a insinuarsi in queste azioni e atti grazie al loro potere allegorico e simbolico.
Lo fa usando delle categorie di pensiero che derivano da filosofi come Jamenson nella forma più postmodernista oppure dal Deleuze de L’Immagine -movimento quando si vuole chiarire i rapporti tra videogioco e cinema. Da una parte quindi Galloway attraverso l’esperienza di videogiochi come Civilization o il più pop (all’epoca) The Sims sembra ricostruire quell’insieme di spazi, architetture culturali, sociali ed economiche che contribuiscono al “rendering della vita” (pag. 10) e ripercorrono quella letteratura che oggi è approdata nella terra promessa dei metaversi.
Dall’altra però c’è un tentativo di comprensione della realtà allegorica prodotta dai videogiochi attraverso l’indagine del cinema e della letteratura con il tentativo di fonderla con la stratificazione prodotta dagli algoritmi (da qui la coniazione del termine allegortimo).
Ed è in questo passaggio che l’indagine critica dell’algoritmo di Galloway sembra fondamentale per capire quanto i videogiochi siano uno specchio perfetto dello zeitgeist del nostro tempo. La quantificazione algoritmica, la struttura rizomatica della rete, la massimizzazione delle rese sono solo alcuni punti di quell’universo che oggi potremmo ricondurre alla gamification e alla tokenizzazione del gioco, in cui il ribaltamento ontologico dell’essenza di gioco, porta a dare un valore ad ogni singola azione sia essa un click, un badge di fan più attivo o di migliore giocatore del mese. In questo la sfida può considerarsi ancora aperta poiché se nella lotta alla disinformazione che corre sui social network, la struttura degli algoritmi ha avuto un ruolo cruciale nel promuovere una comunicazione esasperata, violenta e persuasiva al solo fine di rendersi più attrattiva alla struttura algoritmica che stava dietro ai meccanismi delle aste pubblicitarie, nella tokenizzazione del gioco l’essenza ancora in costruzione degli algoritmi può ancora determinare il carattere, la qualità e l’etica della creazione dei contenuti del futuro.
Non è un caso che Tim Sweeney, uno dei padri fondatori di Fortnite, ha definito il nuovo Internet come un gigantesco parco giochi in cui gli utenti, i giocatori e i creatori di contenuti convergono in un’unica attività che sarà quella del programmatore.
In questo senso suonano profetiche le battute finali di Gallowey in cui affidava al contro-gaming il compito di costituire una avanguardia del videogioco per fini culturali o politici e agli artisti l’obbligo di creare nuove “grammatiche della visione” per “reinventare la posizione del gioco nel mondo” (pag.163).
Se pensiamo a piattaforme come Sandbox, definito dai fondatori come una gigantesca sabbiera digitale, in cui i giocatori possono costruire castelli, comprare terreni virtuali dove programmare il proprio videogioco senza basi specifiche di programmazione al fine di rivendere i propri contenuti, capiamo di essere già difronte ad un mondo in cui non possiamo essere solo spettatori ma, nello stesso modo in cui non è più possibile non combattere la disinformazione prodotta dai social network, probabilmente dovremmo anche decidere se essere semplici giocatori oppure essere dei buoni giocatori.
Altrimenti qualcuno deciderà per noi.
Immagine di copertina: ph. Carl Raw da Unsplash


