Questo testo racconta la storia di un circolo vizioso. Il numero di lavoratori delle industrie culturali e creative è aumentato costantemente per decenni, mentre il valore del loro lavoro è tendenzialmente declinato. Ma quali sono, nel dettaglio, i meccanismi di questo crollo? E quali sono le risposte possibili che si profilano all’orizzonte?

Il saggio di Bertram Niessen è estratto dal voliume Platform Capitalism (Mimesis) a cura di Emiliana Armano, Annalisa Murgia, Maurizio Teli
Nella prima parte di questo capitolo analizzerò brevemente alcune delle principali dinamiche sociali, tecnologiche e politiche che hanno causato questa situazione. Nella seconda, prenderò in considerazione alcune delle principali pratiche utilizzate per cercare delle soluzioni.
ICC: la promessa del nuovo boom, la classe creativa e il nuovo spirito del capitalismo
Negli ultimi decenni è aumentato esponenzialmente il numero di figure con curricula professionali legati alla creatività, alla cultura e all’arte, di pari passo con l’ampliamento di quel vasto settore del terziario avanzato che va sotto la definizione di Industrie Culturali e Creative (ICC).
Sotto la definizione di ICC ricadono settori molto diversi tra loro. Una tassonomia utile per quanto trattato in questo capitolo è quella adottata dalla Fondazione Symbola, che include: arti performative e arti visive; gestione del patrimonio storico artistico (che comprende tutte le attività che hanno a che fare con la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio, come musei, archivi, biblioteche, monumenti, ecc.); industrie culturali (attività orientate alla produzione di beni che operano con modalità industriali basandosi su contenuti ad alto tasso creativo o culturale: cinema, televisione, editoria, industria musicale, videogiochi, ecc.); industrie creative (attività legate al mondo dei servizi che hanno negli elementi immateriali il loro carburante principale: design, architettura e comunicazione); produzione di beni e servizi creative-driven (quelle attività che trovano il proprio valore aggiunto nella cultura e nella creatività pur senza esservi direttamente collegate).
In un’economia sempre più terziarizzata e globalizzata, in cui la produzione materiale è stata delocalizzata lontano dai paesi occidentali, la risposta delle politiche ha puntato sul tentativo di creazione di un nuovo paradigma economico incentrato sul valore immateriale prodotto dalla cultura, dal design e dai media.
Questo approccio è stato definito nel Regno Unito a partire dalla metà degli anni ’90 ad opera del British Department for Culture, Media and Sport, influendo negli anni successivi sia sulle linee di sviluppo dell’Unione Europea che sulle politiche di sviluppo economico molti altri paesi.
I primi anni 2000 hanno segnato un momento di grande effervescenza retorica riguardo alle supposte possibilità di produzione di valore da parte delle ICC. In questo meccanismo ha giocato un ruolo determinante la mitologia della Creative Class – elaborata da Richard Florida e ripresa all’interno di meccanismi di politiche di sviluppo locale su scala globale – secondo la quale la concentrazione di lavoratori creativi negli spazi urbani è sufficiente ad attrarre aziende, investitori e benessere generalizzato.
Gli studi degli ultimi dieci anni hanno dimostrato che non è così. I lavori in questi settori, infatti, sono sempre più caratterizzati da temporaneità, precarietà e intermittenza. Gli orari tendono ad essere spropositatamente lunghi e gli schemi di lavoro bulimici; le paghe inevitabilmente basse. I livelli di mobilità sono tipicamente molto alti, e ne consegue un’auto-percezione come monadi irriducibili alle appartenenze tipicamente moderne come quelle legate allo stato-nazione o alla classe e la concezione del percorso di vita come di un susseguirsi di progetti a breve o medio termine da organizzare secondo un’ottica manageriale.
Allo stesso tempo, questa individualizzazione produce un attaccamento emotivo e identitario al lavoro da parte dei lavoratori creativi: per chi lavora in contesti nei quali la creatività è il nodo attorno al quale si sviluppa la quotidianità della professione, molte forme di sfruttamento e auto-sfruttamento passano attraverso l’utilizzo di un vocabolario legato agli affetti, in contesti che negano le differenze di classe. Negli ambienti di lavoro altamente informali delle ICC si sviluppano forme peculiari, se non separate, di socialità corredate da profonde esperienze di ansia e insicurezza dovute all’instabilità economica.
È fondamentale, a questo punto, sottolineare la specificità culturale della costruzione identitaria dei lavoratori delle ICC. Più di ogni altra tipologia di lavoratori, infatti, quelli che operano nei settori dell’arte, della cultura e della creatività hanno subìto l’impatto del cosiddetto processo di individualizzazione: la definizione del sé come ‘unico’ e ‘speciale’, dotato di un’individualità sempre più distinta dal resto del corpo sociale, che ha comportato crescente differenziazione delle forme di consumo e la ricerca di forme identitarie sempre più particolari.
Nei suoi aspetti più negativi, questo processo ha corroso i legami di coesione sociale che costituivano molte delle premesse del vivere comune, rendendo al contempo le istanze di trasformazione politica sempre più parcellizzate e difficili da mettere in relazione tra loro attraverso movimenti collettivi. Se nelle stagioni di mobilitazione politica generalizzata la ricerca dell’unicità ha costituito uno strumento fenomenale di soggettivizzazione di istanze, gruppi, pratiche e idee altrimenti marginali, nelle fasi di riflusso il sentirsi sempre e comunque diversi da tutti gli altri sembra aver costruito un sostrato ideologico di de-potenziamento dell’azione collettiva.
Questi processi sono stati messi a fuoco da Boltanski e Chiapello, i quali ne ‘Il nuovo spirito del capitalismo’ descrivono come le società occidentali post-sessantotto abbiano metabolizzato la critica esistenziale mossa al capitalismo, mettendola a sistema e trasformandola in uno dei propri principali meccanismi di produzione del valore.
In questo modo, il rifiuto dell’autorità è divenuto un efficiente metodo di innovazione del management; l’espressione del desiderio uno strumento di superamento dell’alienazione della società dei consumi; autenticità, anticonformismo e creatività le ideologie che articolano i discorsi di società a tutti gli effetti sempre più ineguali. In quest’ottica, i lavoratori delle ICC sono stati spesso, anche involontariamente, la punta di diamante dello spirito del nuovo capitalismo, inseguendo un sogno di realizzazione personale in un costante equilibrismo tra la ricerca dell’autenticità (sposando quindi la critica ‘bohémienne’ alla standardizzazione del mondo moderno) e l’iper-precarizzazione delle condizioni lavorative e di vita.

Tutto ciò è avvenuto in un contesto in cui la proliferazione di regimi retorici costruiti attorno alle ICC – come abbiamo visto – ha costruito un immaginario collettivo secondo il quale le nuove professioni legate alla creatività avrebbero permesso non solo una piena realizzazione delle proprie aspettative identitarie, ma anche di quelle economiche. Non è andata esattamente in questo modo. Per capirne le ragioni è importante prendere in considerazione il quadro più ampio delle promesse disattese del neoliberismo, segnato da precarizzazione del mercato del lavoro, contrazione dei sistemi di welfare e finanziarizzazione della produzione del valore. Si tratta da un lato di trasformazioni di ordine generale, che hanno coinvolto la stragrande maggioranza degli abitanti dei paesi ricchi.
D’altro lato ci sono dinamiche che si configurano invece in modo molto più specifico, che hanno a che fare con il ruolo della produzione immateriale nell’economia contemporanea. Sono trasformazioni che riguardano strettamente i lavoratori delle ICC e impattano in modo diretto sia sulla criticità della loro situazione che sulla difficoltà di definizione di nuove strategie per superarle.
UGC: la finanziarizzazione del valore simbolico tra immateriale e materiale
L’escalation vertiginosa di innovazioni tecnologiche legate allo sviluppo di Internet e dei media digitali ha messo rapidamente in crisi il sistema di definizione del valore economico che avrebbe dovuto garantire prosperità grazie alla creatività.
Il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol), ancora alla base di una parte significativa della comunicazione web contemporanea, è stato stabilito solo nel 1991. Pochi mesi dopo è stato pubblicato il primo sito web della storia, presso il CERN di Ginevra.
Nel 1993 è stato rilasciato il primo browser di navigazione per Internet che permetteva una navigazione multimediale relativamente semplice ed intuitiva, Mosaic.
A partire dalla metà degli anni ’90, nell’arco di pochissimo tempo la connettività domestica è aumentata e contestualmente personal computer sempre più potenti hanno iniziato ad essere accessibili ad un numero crescente di persone.
Nello stesso periodo l’industria delle ICT (Information and Communication Technologies) ha iniziato a prendere una forma simile a quella che conosciamo oggi, basata sulla proliferazione di start-up finanziate da fondi di investimento dedicati e il progressivo consolidamento di nuovi colossi imprenditoriali che accentrano potere tecnologico, mediatico e finanziario.
L’inizio degli anni 2000 ha coinciso con la diffusione di massa dell’utilizzo di formati di compressione digitale come i vari MPEG, che hanno reso possibile la forte compressione delle informazioni audio e video. Oltre che per la creazione di file estremamente leggeri che contenessero videoclip, documentari e film, queste tecnologie hanno portato alla nascita del formato MP3, divenuto in breve tempo lo standard per lo scambio dei file musicali su Internet. Nello stesso periodo si sono diffusi protocolli di condivisione tra pari (peer-to-peer file sharing, o P2P) che hanno reso possibile scambiare tra singoli utenti anonimi i file compressi. In estrema sintesi, la rapida convergenza di queste tecnologie ha reso possibile a masse di utenti sparse per il mondo di scambiare in modo relativamente anonimo e sicuro enormi quantità di contenuti informativi: una catena che ha permesso la violazione sistematica e su scala globale di quei diritti di proprietà intellettuale per la musica, i film, le immagini, i software e i videogiochi che avrebbero dovuto, teoricamente, garantire la crescita del valore prodotto dalle ICC.
A partire dalla metà degli anni 2000 la situazione è stata resa ancora più complessa dall’avvento del cosiddetto Web 2.0, un insieme di tecnologie e logiche di gestione dell’informazione che hanno permesso un’ulteriore collaborazione di massa degli utenti e l’aggregazione di dati provenienti da fonti diverse su piattaforme dedicate.
È qui che hanno iniziato a proliferare le piattaforme di social networking basate sui contenuti generati dagli utenti (UGC, User Generated Contents) come Flickr e YouTube, sulle quali vengono caricati quotidianamente milioni di file prodotti da utenti professionisti e amatoriali. I contenuti sui quali si basa la generazione del valore hanno iniziato ad essere sempre meno forniti, quindi, dai lavoratori delle ICC nell’ambito di meccanismi di produzione tradizionalmente remunerati e sempre più creati gratuitamente, invece, da centinaia di milioni di utenti.
È riferendosi agli utenti di queste piattaforme che si è iniziato a parlare di prosumer, figure ibride che sono allo stesso tempo produttrici e consumatrici di contenuti .
Il prosumerism – come viene talvolta chiamato – rende ulteriormente complessa la definizione del valore unitario della produzione creativa. In un mondo nel quale letteralmente centinaia di milioni di siti, blog, piattaforme e profili sui social network traboccano di immagini, testi, video e suoni è decisamente più difficile (se non impossibile) stabilire il valore unitario di un singolo prodotto creativo.
Permangono, è vero, numerose opere d’ingegno che possono essere solo il prodotto di processi articolati di produzione industriale nei quali la professionalità specifica dei lavoratori creativi è un elemento insostituibile. Si tratta tuttavia di una percentuale decrescente dei consumi culturali globali, in un panorama marcato da crescenti difficoltà. Inoltre, l’estrazione del valore prodotto dai lavoratori delle ICC non avviene solo attraverso piattaforme generaliste come i social network più diffusi, ma anche tramite siti dedicati che utilizzano il crowdsourcing, l’esternalizzazione digitale di massa di servizi.
Per molte aziende – specialmente per quelle di piccole dimensioni – oggi è molto più conveniente indire concorsi al ribasso su scala globale per il design dei loghi e dell’immagine coordinata che non assumere uno studio o dei liberi professionisti.
Affidandosi a piattaforme come 99Design o Design Crowdsourcing il risultato sarà forse di ordine qualitativo più basso, ma per la legge dei grandi numeri tra studenti e freelance qualcosa di accettabile salterà fuori comunque.
Come ho illustrato nelle precedentement, le promesse di costruzione di valore diffuso implicite nello sviluppo delle ICC sono state in buona parte disattese.
In estrema sintesi, le ragioni sono da ricondurre alla convergenza di una serie di trasformazioni che hanno a che fare con lo sviluppo di una logica di creazione e estrazione del valore diverse da quelle che si erano ipotizzate negli anni ’90. È vero, infatti, che una parte crescente del valore economico viene prodotto grazie alla produzione di contenuti culturali; lungi dall’essere redistribuito ai produttori, questo viene però estratto e accumulato dai colossi di quello che Michel Bauwens chiama Netarchical Capitalism, una classe di capitalismo che non dipende più dalla proprietà dei diritti intellettuali né dal controllo dei vettori di produzione, e che basa la propria ricchezza sullo sviluppo e il controllo delle piattaforme .
Il valore simbolico legato ai contenuti culturali è in misura crescente, in ultima istanza, una componente del valore finanziario degli attori del Netarchical Capitalism. Una ricchezza che è tutto tranne che accumulata per essere ridistribuita.
Gilde, attivismo e nuove piattaforme cooperative
Nelle pagine precedenti ho sottolineato le contraddizioni intrinseche nel circolo vizioso che si è costruito tra sviluppo delle ICC, innovazione tecnologica, processo di individualizzazione e finanziarizzazione dell’economia, ponendo l’accento soprattutto sulle criticità di tipo sistemico.
I lavoratori della cultura e della creatività, tuttavia, sono da sempre alla ricerca di forme di auto-organizzazione che consentano una maggiore capacità di negoziazione. L’organizzazione sindacale dei lavoratori del settore culturale, per esempio, ha radici antiche. Corina L. Apostol ne ha tracciato una genealogia che, partendo dalla Federazione degli Artisti nata durante la Comune di
Parigi arriva fino ai giorni nostri, passando per il Sindacato Operai Tecnici, Pittori e Scultori del Messico rivoluzionario, la Gilda degli Artisti di Harlem, l’Art Workers’ Coalition e l’Associazione per l’Equo Trattamento degli Artisti negli Stati Uniti (che conta oltre 50.000 iscritti).
Nonostante la loro importanza, tuttavia, solo in rari casi e in congiunture politiche particolari queste organizzazioni sono riuscite a farsi protagoniste di mutamenti sostanziali delle condizioni contrattuali e, di conseguenza, di influire sui percorsi di carriera.
Vista nel quadro storico più ampio delle grandi mobilitazioni per il lavoro, l’estrema settorializzazione delle lotte dei lavoratori della cultura e dell’arte sembra in generale aver dato poco respiro all’analisi e alle soluzioni proposte. In generale, infatti, le carriere dei lavoratori della cultura hanno sempre mostrato sintomi dei fenomeni che abbiamo tratteggiato: non è un caso che in tempi recenti si stia riscoprendo in Italia la figura di Luciano Bianciardi, che già tra la fine degli anni ’50 e i primi ’60 aveva delineato spietatamente (in una serie di romanzi, articoli e pamphlet) molti dei tratti che ancora oggi caratterizzano le carriere dei lavoratori culturali, primo tra tutti una costante tendenza all’individualismo.
È solo con i movimenti post-Seattle degli anni 2000 che si è assistito all’insorgere di pratiche e critiche articolate che hanno cercato di superare le rivendicazioni di settore per costruire piattaforme più ampie che tenessero conto dei mutati paradigmi di produzione.
È stato in quel periodo che attorno alle organizzazioni di media tattici e indipendenti come Indymedia si sono aggregati su scala globale collettivi di attivisti che spesso univano percorsi professionali nelle ICC (in quanto videomaker, fotografi, giornalisti, ma anche designer e programmatori) con la ricerca di nuove pratiche espressive basate sulla manipolazione dei sistemi simbolici dei media mainstream e l’attenzione alla precarizzazione generalizzata dei rapporti lavorativi.
Si tratta di tutto quel mondo sviluppatosi attorno al subvertising: un termine originato dalla crasi di subvert (sovvertire) e advertising (pubblicità); una tattica di attivismo politico – sviluppata nell’ambito delle avanguardie politico-artistiche della seconda metà del Novecento come l’Internazionale Lettrista, l’Internazionale Situazionista, i Provos e i Merry Pranksters – che consiste nel produrre false campagne pubblicitarie utilizzando grafica e stili comunicativi delle pubblicità reali per veicolare messaggi politicamente dissonanti rispetto agli originali.
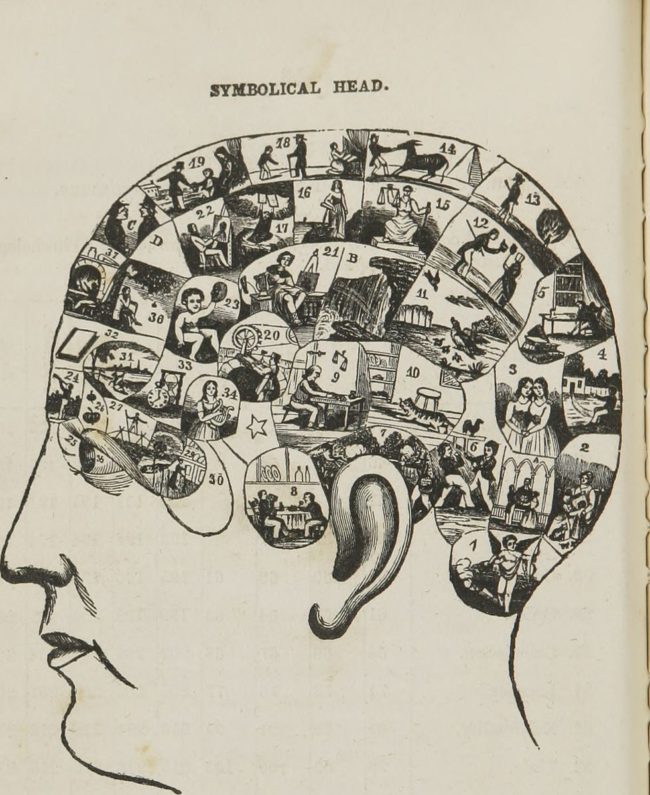
Ne sono un esempio i percorsi di San Precario e Serpica Naro, nomi collettivi sotto i quali hanno agito gruppi di studio e azione contro le trasformazioni neo-liberiste del mercato del lavoro.
Le azioni di San Precario si caratterizzano per l’utilizzo estremamente consapevole di tecniche di comunicazione e marketing sofisticate per veicolare messaggi politici.
Serpica Naro, suo alter ego femminile, ha iniziato la propria carriera con una finta sfilata per la settimana della Moda a Milano nel 2005; la misteriosa sfilata dell’omonima stilista giapponese, assediata da giornalisti e fotografi assetati di contenuti esclusivi, si è poi rivelata una performance per denunciare le condizioni di precarietà dei lavoratori della moda, orchestrata con la complicità di molti creativi inseriti in diverse filiere di produzione. In entrambi i casi, così come in molti omologhi internazionali, il riflusso dei movimenti sociali della seconda metà degli anni 2000 ha portato a una contrazione o a un vero e proprio arresto delle attività.
Linfa nuova è arrivata dalla stagione delle proteste legata agli Indignados e a Occupy, durante la quale sia le pratiche di autorganizzazione che quelle mediattiviste si sono rivitalizzate sulla base di nuove forme di protesta e organizzazione orizzontale e reticolare.
W.A.G.E. (Working Artists and the Greater Economy), ad esempio, è un’organizzazione con sede a New York che coniuga la tipica cifra stilistica di Occupy con istanze di base relative all’equità lavorativa; si occupa di regolare in modo trasparente e certificare il pagamento dei compensi degli artisti da parte delle istituzioni culturali non-profit, combattendo la precarizzazione e promuovendo contratti di lavoro a lungo termine.
ArtLeaks è invece una piattaforma internazionale avviata da un gruppo di artisti, curatori e storici dell’arte con l’obiettivo di adattare la metodologia di whistleblowing sviluppata da WikiLeaks al settore specifico del mondo dell’arte, denunciando trattamenti contrattuali non equi, situazioni di management sospetto e rapporti genericamente ritenuti eticamente inaccettabili.
Nonostante la visibilità internazionale di cui hanno goduto iniziative queste iniziative, si tratta di pratiche marginali che impattano su un numero estremamente limitato di casi. Il sistema di certificazione di W.A.G.E., ad esempio, è adottato da appena 33 organizzazioni in tutti gli Stati Uniti, e si tratta quasi sempre di piccolissimi spazi indipendenti per l’arte.
Spazi: occupazioni e coworking
Una delle strategie di autorganizzazione che sembra aver dato i frutti più interessanti è legata all’innovazione di pratica tradizionale dei movimenti sociali: le occupazioni.
Le occupazioni illegali a scopo prevalentemente artistico (che possono prevedere o meno, cioè, l’uso abitativo, ma che hanno nella produzione e distribuzione di contenuti artistici e culturali la loro prima ragione di esistere) non sono certo una novità, e risalgono almeno agli anni ’60.
Quella che per molti anni è stata la più nota, la Kunsthaus Tacheles, è stata occupata nel 1990 da artisti statunitensi e inglesi sulla centralissima Oranienburgerstrasse di Berlino: connotata fin da subito come art squat, è stata progressivamente inglobata all’interno del sistema della leisure delle vie circostanti, fino a trasformarsi in una delle principali attrazioni turistiche della zona e, infine, ad essere demolita all’interno di un processo di rigenerazione urbana su larga scala.
Alcuni dei casi più rilevanti nella nuova ondata post-Occupy di mobilitazione dei lavoratori dell’arte sono avvenuti in Italia, all’interno di un ciclo di mobilitazione politica identificato da alcuni come ‘stagione dei teatri occupati’.
Anche se esiste una rete di coordinamento tra queste realtà, in buona parte separata da quelle tradizionali legate ai movimenti degli anni ’90, ogni occupazione è in realtà un caso a sé stante sia dal punto di vista delle piattaforme di rivendicazione che da quello dell’effettivo impatto sulle politiche culturali locali.
Il Teatro Valle è probabilmente il caso più noto: si tratta di uno spazio occupato a Roma il 14 giugno 2011 da un gruppo di lavoratori dello spettacolo e attivisti affinché lo stabile venisse mantenuto pubblico attraverso meccanismi di partecipazione popolare.
Nei tre anni di autogestione, gli occupanti hanno coinvolto artisti e intellettuali di fama internazionale, elaborando nuove proposte di gestione dei teatri pubblici e, più in generale, sviluppando un quadro di pratiche e analisi volto alla ridefinizione della cultura come bene comune.
L’esito non scontato di questa operazione è stato, dopo 27 mesi, la creazione di una fondazione con 5600 soci con l’obiettivo di gestire il bene culturale come bene comune; la fine dell’occupazione, nell’agosto 2014, e la conseguente consegna del teatro alle autorità non hanno però, al momento in cui scrivo, portato ad uno sviluppo significativo della questione.
Altrettanto significativa è la serie di occupazioni portate avanti dal collettivo Macao a Milano, con lo scopo di costruire una piattaforma cittadina per le rivendicazioni dei lavoratori dell’arte e della cultura, iniziate con la spettacolare occupazione di un grattacielo abbandonato di 33 piani vicino alla Stazione Centrale – la Torre Galfa – e approdate nel giugno 2012 agli ex-macelli abbandonati nella periferia est, dove tuttora risiede il progetto.
Uno degli aspetti più interessanti della ‘stagione dei teatri occupati’ è il fatto che il movimento abbia programmaticamente superato i linguaggi e l’iconografia dei precedenti movimenti sociali, riuscendo così ad ampliare la propria base di consenso dialogando con soggetti, gruppi e organizzazioni che non rientravano nel repertorio degli interlocutori tradizionali della sinistra extra-parlamentare.
Le occupazioni non sono l’unico caso in cui gli spazi fisici hanno offerto l’opportunità ai lavoratori delle ICC di sperimentare nuove forme di collaborazione sociale e politica.
Il fenomeno dei co-coworking sembra, di primo acchito, qualcosa di molto lontano da quello di cui stiamo parlando. Si tratta di una tipologia di luoghi nata in California negli anni ’90 con l’obiettivo di fornire ai lavoratori freelance delle industrie dell’informazione spazi comuni relativamente a basso costo: lungi dal limitarsi ad essere una pura e semplice esperienza di desk-sharing (condivisione di scrivanie), i coworking hanno costituito un’opportunità per socializzare saperi taciti e espliciti relativi alle problematiche del lavoro che si è sviluppata rapidamente in tutti i paesi caratterizzati da un’alta presenza di lavoratori immateriali.
Dal punto di vista politico si tratta spesso di figure di segno decisamente diverso rispetto a quelle di cui abbiamo parlato nelle righe precedenti, vale a dire dei lavoratori cognitivi che si riconoscono nella narrazione dell’auto-imprenditorialità nata dallideologia californiana’. Si tratta di un ibrido tra libertarismo post-hippy, soluzionismo manageriale, tecno-determinismo e turbo- capitalismo che (se già presenta evidenti criticità nel suo contesto di provenienza, la Sylicon Valley delle start-up e delle mega-corporations del web 2.0) mostra tutto il peso della propria natura colonizzatrice dell’immaginario in quei paesi dove gli ecosistemi articolati di start up e fondi di investimento dedicati sono là da venire.
Questa adesione spesso entusiastica alle forme ideologiche del neoliberismo, così come la costituzione di catene in franchising spesso di proprietà di grandi aziende, ha spinto molti osservatori a vedere i co-working come lo spazio ultimo dell’accettazione delle logiche dello sfruttamento. Ciononostante, negli ultimi anni un numero crescente di spazi si stanno sviluppando espressamente nell’ottica della costituzione di pratiche di mutualismo: è il caso di Supermarkt a Berlino (‘una piattaforma per la cultura digitale, le economie alternative e le nuove forme di lavoro’) e dello Spazio Kilowatt a Bologna (che si propone come ‘un progetto modulare con l’obiettivo di stimolare la nascita di nuove opportunità di lavoro, nuove collaborazioni professionali e relazioni sociali, nuovi spazi di inclusione, di socialità e di welfare, grazie ad attività di facilitazione concreta per chi vuole fare impresa, di supporto per mamme e padri freelance, per chi ha delle idee innovative.
Il tutto in un luogo di confronto culturale e di contaminazione tra gli innovatori e la cittadinanza, il mondo dell’impresa, il terzo settore e la pubblica amministrazione’).
Allo stesso tempo, si stanno rinsaldando i legami tra le organizzazioni per la rivendicazione dei diritti dei consulenti e dei free-lance ed alcune reti di co-working.
In Italia è la strategia portata avanti da ACTA (Coworking | ACTA, L’associazione Dei Freelance n.d.). ACTA è la prima associazione costituita in Italia per dare rappresentanza ai professionisti del ‘terziario avanzato’ che sono lavoratori autonomi: formatori, ricercatori, informatici, creativi e altre categorie di consulenti, generalmente operanti al di fuori di Ordini e Albi professionali, tutte accomunate dal rivolgersi a clienti che sono imprese o enti della Pubblica Amministrazione.
Anche in questi casi, come è facile immaginare, i sistemi di rappresentazione utilizzati sono lontani anni luce da quelli tradizionali dei movimenti sociali, mutualistici e sindacali, e questo permette il dialogo con realtà fino a poco tempo prima lontanissime.
Alcuni osservatori si sono spinti a vedere in questo allargamento della base sociale delle forme di consapevolezza (se non di protesta) contro la precarietà la costituzione di una nuova composizione di classe – un ‘Quinto Stato’ – costituito da migranti, lavoratori precari e freelance.
Nuove piattaforme tra digitale e materiale
Alcune delle pratiche di auto-organizzazione più interessanti dei lavoratori della cultura si muovono in spazi virtuali, soprattutto per quello che riguarda gli strumenti per il perseguimento di forme di sostenibilità economica. In questo senso, le piattaforme di crowdfunding – che permettono la raccolta di fondi per progetti specifici allargata a grandi gruppi di persone – hanno sicuramente rappresentato la più grossa novità degli ultimi anni.
Le piattaforme più utilizzate hanno delle logiche e dei modelli di diffusione basati sulle retoriche delle industrie californiane dell’IT; nonostante questo, continuano a essere privilegiate anche per il finanziamento di progetti culturali che hanno una vocazione sociale e politica perché teoricamente permettono di raggiungere numeri molto più grandi di potenziali finanziatori.
Effettivamente, alcune campagne di crowdfunding realizzate in questo modo hanno raggiunto dei risultati impressionanti, come quella per il documentario ‘Io sto con la sposa’, che attraverso IndieGoGo ha raccolto in due mesi quasi 100.000 euro (a fronte di un obiettivo iniziale di 75.000) e riuscendo anche grazie alla comunicazione fatta a proiettare il film alla Mostra del Cinema di Venezia e a dotarlo di una distribuzione nazionale e internazionale normalmente impensabile per una piccolissima produzione indipendente.
Altre piattaforme (come Patreon) permettono di finanziare un artista senza vincolare le donazioni ad un progetto specifico, proponendosi di ‘aiutare ogni creativo nel mondo a raggiungere un reddito sostenibile’.
Un numero sempre maggiore di progettisti preferisce rivolgersi a piattaforme indipendenti come Goteo o Produzioni Dal Basso, che tematizzano in modo esplicito le criticità del capitalismo contemporaneo e che si propongono di contribuire a fornire la costituzione di nuove comunità economiche basate sulla collaborazione, la condivisione della conoscenza e gli equi compensi dei collaboratori.
Sempre più spesso, a questo tipo di piattaforme si accompagnano set di strumenti di disintermediazione ed emancipazione sociale, economica e culturale a disposizione dei progettisti, come sistemi di monete digitali alternative o complementari o kit per imparare e diffondere specifiche metodologie.
Si tratta di un punto importante di intersezione con il mondo dei co- working più politicamente sensibili menzionati poche righe prima.
Allo stesso tempo, in diversi paesi si stanno sperimentando reti di welfare parallelo specificatamente dedicate ai lavoratori della cultura, proprio in virtù dell’alto livello di precarizzazione e frammentazione delle loro dinamiche lavorative. Uno dei sistemi di maggior successo è sicuramente SMart, una piattaforma di servizi per i professionisti dello spettacolo, delle arti e del settore creativo presente in otto paesi europei e con un totale di 60.000 aderenti, organizzata in una rete di sostegno alla mobilità di artisti e opere che agisce a favore delle imprese di settore e della creazione di uno statuto sociale e fiscale dell’artista tramite la costituzione di fondi di garanzia per i pagamenti dei compensi e l’organizzazione di corsi di aggiornamento in temi economici, legali e fiscali.
Lìberos, invece, costituisce un interessante esempio di organizzazione ‘di filiera’: una rete sociale peer-to-peer che organizza in modo innovativo soggetti situati in diversi punti della filiera editoriale, mettendo assieme produzione, distribuzione e fruizione.
In Lìberos sono riuniti scrittori, editori, librai, biblioteche, associazioni culturali, festival letterari e altri professionisti dell’editoria sarda. Lìberos ha iniziato a operare in Sardegna nel luglio del 2012 come gruppo informale, costituitosi per reagire ad una specifica situazione di emergenza (il rischio di chiusura di una libreria indipendente sarda).
Da subito il gruppo si è caratterizzato per una notevole capacità di organizzazione e per una concezione innovativa delle pratiche d’intervento. Da un lato, infatti, ha saputo raggiungere in tempi eccezionalmente brevi un gran numero di singoli, gruppi e istituzioni diverse sparse su tutto il territorio regionale. Dall’altro, ha utilizzato strategie di azione e comunicazione non convenzionali in un settore relativamente tradizionale come quello librario; costituisce un caso emblematico in questo senso uno dei loro primi interventi, chiamato ‘#occupylibreria’, nel quale gli stakeholders venivano chiamati ad utilizzare gli spazi di una libreria in difficoltà con concerti, reading, cene e pernottamenti in sacco a pelo.
Il panorama delle pratiche di auto-organizzazione è costantemente in evoluzione, e molto spesso è difficile circoscriverle ai soli lavoratori della cultura.
L’esperienza di precarietà lavorativa e biografica è ormai generalizzata, e molte delle piattaforme che vengono utilizzate in ambito culturale facilitano l’interazione con percorsi molto diversi, che vanno dai movimenti sociali legati alla sinistra extra-parlamentare agli entusiasti del mito delle start-up californiane, passando per attivisti civici che tentano il rinnovamento delle pubbliche amministrazioni e per i mondi estremamente frammentati dell’innovazione sociale e alcuni ambienti del terzo settore cooperativo di matrice socialista o cattolica.
Questa trasversalità è forse, al tempo stesso, il principale punto di forza e di debolezza delle forme di autorganizzazione dei lavoratori della cultura. Da un lato, infatti, abbiamo visto come queste pratiche si stiano diffondendo presso gruppi sociali precedentemente lontanissimi; dall’altro, tuttavia, la cultura prevalente in questi gruppi spesso rifugge forme esplicite di conflitto, minimizzando le differenze di classe in un regime di totale incorporazione del ‘nuovo spirito del capitalismo’.
Nuovi paradigmi del valore e azione collettiva
Al termine di questo excursus possiamo fare alcune considerazioni. La situazione di crisi dei lavoratori delle ICC può essere letta come il risultato di una serie di tendenze di lungo percorso che hanno a che fare da un lato con le trasformazioni delle soggettività verso una crescente individualizzazione declinata nell’ottica dell’ideologia della creatività e dall’altro con i grandi cambiamenti portati dall’economia postfordista: finanziarizzazione, globalizzazione ed economia delle piattaforme. Le pratiche di autorganizzazione messe in atto fino ad oggi cercano prevalentemente di porre rimedi particolari e parziali a criticità specifiche, senza riuscire a interrogarsi realmente a livello collettivo su quali misure sia possibile adottare per modificare i rapporti di potere su scala più globale.
Quello che manca è, innanzitutto, una diversa visione di come il valore viene prodotto e messo in circolazione. Come hanno messo in evidenza Arvidsson e Peitersen, infatti, la ‘crisi perenne’ del capitalismo contemporaneo può essere letta soprattutto come una crisi della definizione comune di valore dal punto di vista della misurazione degli asset economici intangibili, sia sulla scala macro che su quella micro.
Per approfondire questo punto può essere utile ricorrere all’analisi di Bourdieu sui quattro tipi di capitale; quattro forme di valore associate a individui e organizzazioni che si producono, circolano e possono convertirsi parzialmente l’una nell’altra secondo logiche determinate da campi di potere estremamente complessi che, in ultima istanza, riflettono i rapporti di forza della società.
Il capitale economico è determinato dal denaro, dalla rendita e dai mezzi di produzione (‘ciò che si ha’); il capitale sociale è costituito dalle reti sociali (‘chi si conosce’); il capitale culturale è definito dai crediti formativi riconosciuti e dalla conoscenza (‘ciò che si sa’); il capitale simbolico è costruito su legittimazione e reputazione (‘ciò che si dice di noi’).
Come detto, queste forme di capitale possono essere parzialmente convertite l’una nell’altra: si può utilizzare il denaro per studiare nelle migliori università e frequentare club esclusivi; la reputazione data da lavori mal pagati ma fortemente riconosciuti può essere messa a frutto per accedere a cerchie sociali migliori della propria; e così via.
Guardando alla situazione attuale dei lavoratori delle ICC, appare evidente la sproporzione tra le diverse forme di capitale e la difficoltà di convertirle una nell’altra.
Lavorare in molti settori delle industrie culturali comporta l’accumulo di titoli di studio, l’apprendimento di più lingue, lo sviluppo di competenze tecniche anche sofisticate, la frequentazione di ambienti e persone con la reputazione ‘giusta’, l’adozione di strategie di personal branding sui social media simili a quelle delle grandi aziende: tutti elementi che consentono l’accumulo di grandi capitali sociali, culturali e simbolici che non si riesce a trasformare in capitale economico. Quello di cui c’è bisogno è la definizione di nuovi paradigmi condivisi del valore che stabiliscano nuove modalità di conversione dei capitali. È un processo che può avvenire solo con l’avvento di nuove forme di rappresentanza trasversali ai diversi settori delle ICC in grado di superare la natura situata e particolaristica dei tentativi puntiformi descritti nelle pagine precedenti.
È però alle forme di autorganizzazione esistenti che dobbiamo guardare per immaginare nuove linee di trasformazione possibili, a partire da reti sperimentali fisiche e virtuali, da spazi ibridi di progettazione, produzione e distribuzione culturale, da strategie di finanziamento alternative. Perché di cosa si tratta se non di tentativi di mettere a valore in modo diverso quelle tipologie di capitali così difficili da convertire?
Ovviamente questo non può avvenire se l’azione collettiva delle nuove forme di rappresentanza non eserciterà una pressione nei confronti della sfera pubblica con l’obiettivo di definire una forma di welfare capace di pensarsi prima di tutto come governance della complessità delle relazioni tra produzione materiale e immateriale, tra capitale culturale e capitale economico, tra creatività individuale e innovazione sociale.


