In questi lunghi mesi di pandemia molti di noi si sono costruiti una piccola bolla di contatti con cui, quando il colore della propria regione, i Dpcm e le variabili individuali lo consentono, si incontra più o meno regolarmente – per carità, sempre mantenendo un’adeguata distanza. Sono contatti stretti, persone con cui si condividono spesso idee e valori, persone a cui si vuol bene. E anche io ne una. Un’amica e due amici con cui cerchiamo di vederci con cadenza regolare.
Questi miei incontri di “bolla” sono spesso di occasione di confronti sempre abbastanza accesi riguardo questioni di genere o più in generale diritti delle donne e loro violazioni. Succede praticamente tutte le volte. E non si tratta di conversazioni con una persona “cattiva”, che tratta male attivamente le donne o tanto meno si considera maschilista. È un uomo che incarna tuttavia il prototipo di quanti, come scrive Michela Murgia nel suo ultimo libro “Stai Zitta” (Einaudi 2021), affermano con orgoglio “io non sono maschilista” e poi in parole, pensieri e alle volte comportamenti, si contraddicono. Sono quanti non notano nella loro quotidianità segni evidenti della cultura del maschilismo, del patriarcato e dell’affermazione del genere femminile in quanto atipico o di minor valore. Tutto questo è talmente radicato nella società da sembrare loro “normale”; non lo ritengono un problema o, meglio ,pensano che sia un retaggio del passato. Sono maschilisti inconsapevoli, come siamo tutti finché non scegliamo di fare attenzione e di provare a cambiare le cose. E noi stessi prima di tutto. “In una cultura patriarcale” – scrive infatti Murgia – “tutti e tutte cresciamo compromessi dal pregiudizio sessista. Smettere di esserlo richiede una scelta personale prima consapevole e poi esplicita, sia per gli uomini che per le donne.”
Questa scelta e questo percorso è ancora oggi molto stigmatizzato e le donne che lo compiono (gli uomini che lo compiono sono purtroppo oggi ben poco valorizzati dalla società, anche se non dalle loro compagne, madri, sorelle, amiche, colleghe e da tutte le donne che hanno a che fare con loro senza essere trattate con condiscendenza o sottoposte a estenuati affermazioni di potere), sono additate, derise, insultate, aggredite, minacciate e, soprattutto, sono donne che sentono continuamente ripetersi: “Non è vero”.
Ma da adesso in poi “Non è vero” non si potrà più dire con leggerezza. Emanuela Griglié e Guido Romeo, nel loro ultimo libro “Per soli uomini. Il maschilismo dei dati dalla ricerca scientifica al design” (Codice edizioni, 2021), mettono infatti a nudo questa infrastruttura maschilista ambito dopo ambito, numeri alla mano. E ancora di più lo fa Caroline Criado-Cortez, autrice di “Invisibili” (Einaudi, 2020) e di una newsletter che trovate qui: (http://newsletter.carolinecriadoperez.com/). E tra i numeri con cui Criado Cortez, Griglié e Romeo mostrano il sistematico favoritismo del genere, anzi del sesso maschile, spesso quelli più importanti sono quelli che non ci sono.
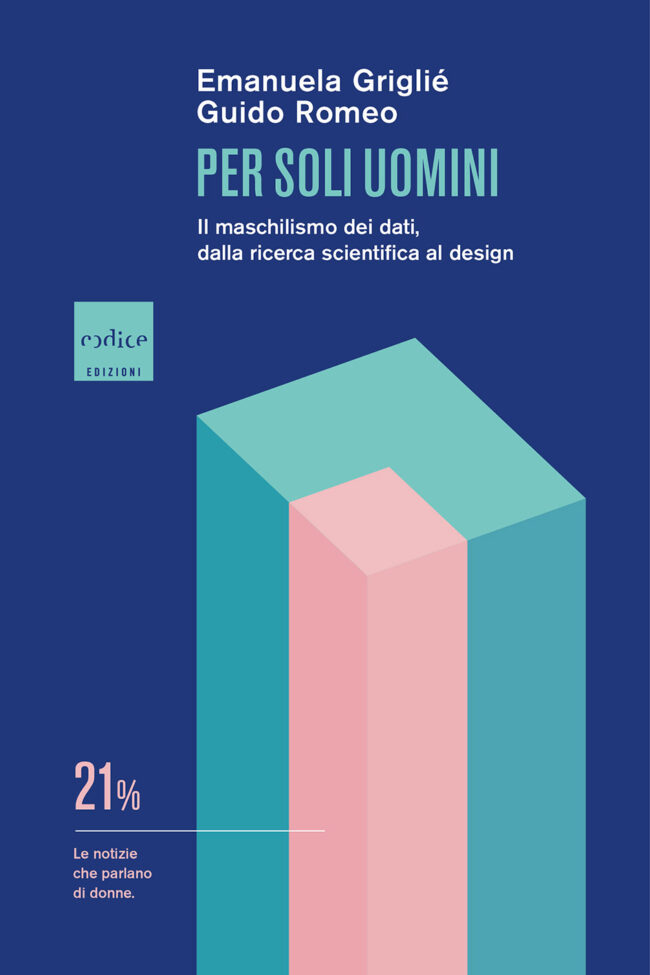
Sì perché i dati che riguardano le donne non ci sono quasi mai e quando ci sono non sono presi in considerazione. È il Gender Data Gap, ovvero il divario tra i dati che riguardano gli uomini e quelli che riguardano le donne a disposizione per i diversi aspetti della vita quotidiana e ambiti della società. Dati raccolti, consultati e adoperati – quelli che riguardano gli uomini e i loro comportamenti, preferenze, ruoli e via dicendo – e dati non raccolti, non consultati e non adoperati, quelli che riguardano le donne. Quello che emerge prepotentemente da questi due libri è che manca l’idea stessa che sia opportuno e necessario di raccogliere dati che riguardano il corpo, la biologia, le attività, i desideri, i bisogni delle donne. Non è considerato importante. Una volta raccolti i dati per gli uomini, quelli vanno bene per tutti. A essere onesti bisognerebbe dire dati per gli uomini bianchi, eterosessuali, di circa 35 anni, 70 chilogrammi di classe sociale medio-alta. Anche se così facendo ci si dimentica di pensare a metà del genere umano (e non solo).
Qualche esempio? Anche se sono più spesso gli uomini ad avere incidenti stradali, quando una donna si mette al volante non sempre è cosciente che sono le donne che hanno maggiore probabilità di andare incontro a un grave infortunio se coinvolte in un incidente. “Una donna vittima di incidente stradale ha il 47% in più di probabilità di restare gravemente ferita, il 71% in più di subire una lesione moderata e il 17% in più di morire. Una simile differenza rispetto all’uomo non è casuale, ma dipende dal modo in cui sono progettate le automobili”, scrivono Emanuela Grigliè e Guido Romeo. Perché se è vero che le auto sono testate per la sicurezza e la resistenza e valutate anche in merito ai danni riportati dai passeggeri in caso di incidente, per decenni i crash test sono stati fatti adoperando solo manichini che si “basano su un maschio del cinquantesimo percentile: alto un metro e 77 e di 75,5 chili, con una massa muscolare e una colonna vertebrale tipicamente maschili”. E questo è vero ancora oggi per molte auto. I manichini “femminili” – che altro non sono che modelli maschili di dimensioni più piccole e che non prendono in considerazione diversa struttura ossea, distribuzione muscolare, e via dicendo – si è cominciato ad adoperarli negli Stati Uniti nel 2011, e spesso solo nel sedile del passeggero.
Altro esempio: una donna che assume un farmaco ha il 75% di probabilità in più di riportare un effetto collaterale. Questo perché nella stragrande maggioranza dei test clinici le donne non sono presenti nel campione di persone su cui si testa un farmaco. Altro esempio ancora. In un ufficio, si sà, sono le donne ad avere sempre più freddo. Il loro metabolismo, infatti, è diverso da quello degli uomini e per loro la temperatura ideale dovrebbe essere di 5°C più alta rispetto a quella ideale per gli uomini, ma i termostati sono regolati su temperature standard decise sulla base di test che hanno coinvolto soprattutto uomini. Ancora uno. Le donne che lavorano nella polizia spesso hanno giubbotti antiproiettile che non le proteggono perché non prendono in considerazione altezza, seno, diversa struttura.
E questi sono esempi semplici e molto pratici. Sono quelli facili da ricordare, ma sono anche quelli che forse rendono meno bene la capillarità di quanto lo standard maschile sia preso come misura unica e di come invece il sesso femminile sia ignorato nel momento di prendere le decisioni. E le conseguenze di questo standard e del circolo vizioso infinito che innesca: finora si è lavorato alla costruzione di una società in cui le donne hanno meno potere economico e istituzionale e minore presenza nelle sedi decisionali – dalla famiglia, all’azienda, al Parlamento – e questo ha portato e continua a portare a un divario di dati di genere che a sua volta porta un ulteriore svantaggio economico e di potere e a una minore di presenza (nelle istituzioni economiche, sanitarie e politiche, ma anche, per esempio, nei media, come mostrano tutti i rapporti del Geena Davis Institute on Gender in Media https://seejane.org/ ) di donne.
Quando poi i dati ci sono, non lasciano dubbi, come mostra il Global Gender Gap Report del World Economic Forum che da 14 anni fotografa la disparità di genere basandosi su criteri che riguardano l’economia, l’istruzione, la politica, la salute, esprimendola con un indice dal valore compreso tra 0 e 1. Quando questo indice è pari a 0,686, come è stato lo scorso anno, allora il divario di genere è stato colmato al 68,6% (questo è un dato medio globale, poi il Report indica anche i valore per ogni paese). Come vedete, di strada ce n’è.
Che i “I dati parlano chiaro”, me lo conferma Cristina Da Rold data journalist e collaboratrice di Infodata 24 del Sole 24 Ore che spesso si è occupata di dati e genere (solo gli ultimi: impatto di covid-19 sul lavoro delle donne, donne e demenze, mansplaining, gender gap salariale in sanità): “E grazie ai dati è possibile dire: ‘le cose stanno così, ci sono dei dati, il luogo comune che conosciamo non rispecchia la realtà dei fatti’”. “Uno dei dati che più mi colpisce”, prosegue la giornalista, “è che ci sono ancora troppe donne – soprattutto nelle classi socioeconomiche più basse – che dipendono ancora completamente dagli uomini”. “Quella del divario di genere non è solo una questione di tetto di cristallo e di posizioni di comando, che pure è un tema fondamentale ed è importante e va sottolineato ogni volta che è necessario. Ma altrettanto importante è raccontare di quelle donne che a 20-30 anni non studiano o non lavorano, o smettono di lavorare dopo il primo figlio e sono a quel punto dipendenti dal marito economicamente ma anche in termini di indipendenza fisica, di decisioni familiari e personali”.
È un punto chiave quello dell’indipendenza, secondo Da Rold. E passa anche da dati che possono non sembrare rilevanti ma lo sono eccome, per esempio il numero di ragazze che prende la patente di guida. “Ci sono tante donne, per esempio, che a 18 anni non prendono la patente. E se una ragazza abita in città, forse ancora può provare a spostarsi con i mezzi pubblici (senza ora prendere in considerazione i problemi di sicurezza). Ma una donna che vive in una cittadina, in un paese di provincia, se non ha la patente è una donna chiusa in casa: non può frequentare, per esempio, un corso fuori dall’orario scolastico o lavorativo, uscire con le amiche, andare a trovare un familiare senza che qualcuno di accompagni, senza chiedere il permesso”. La minore indipendenza è mostrata anche, per esempio, da dati come il gender gap salariale (in Italia per esempio è del 5,5% tra laureati e dell’8% tra non laureati a sfavore delle donne) o l’altissimo numero di ore che le donne dedicano al lavoro di assistenza e cura non retribuito e che riducono la loro possibilità invece di dedicarsi ad attività di lavoro retribuite, a migliorare la loro istruzione o il loro status socio economico. In Italia, secondo l’International Labour Organization, le donne svolgono 5 ore e 5 minuti di lavoro non retribuito di assistenza e cura al giorno mentre gli uomini un’ora e 48 minuti, in percentuale le prime si fanno carico del 74% delle ore totali). Altri dati molto più espliciti e si trovano poi ne “L’atlante delle donne” di Joni Seager (add editore, 2020): violenza domestica, obbedienza imposta per legge, istruzione, anni di scuola, stupro e via dicendo.
Quello che emerge da tutti questi libri e che toglie il fiato è come il gender gap e il gender data gap riguardino ogni singola sfera della vita, come le espressioni di questi divari siano così fortemente intrecciate tra loro e come le conseguenze vadano ad amplificarsi e a risuonare tra loro nei diversi ambiti della società. Con ricadute negative per tutti. La questione del gap di genere è talmente trasversale e fondamentale che ne parla anche Bill Gates nel suo ultimo volume “Clima. Come evitare un disastro” (Mondadori, 2021): “Le donne non sono l’unico gruppo vulnerabile ma sono il più grande. Per diverse ragioni – culturali, politiche, economiche – le donne contadine hanno più difficoltà degli uomini. Ad esempio, potrebbero non essere in grado di esercitare diritti sulla terra, o avere pari accesso all’acqua, o ottenere finanziamenti per acquistare fertilizzanti, o persino essere in grado di ottenere previsioni meteorologiche. Quindi dobbiamo fare cose come promuovere i diritti di proprietà delle donne e formulare attività di consulenza tecnica specifiche per loro. Il ritorno potrebbe essere significativo: uno studio di un’agenzia delle Nazioni Unite ha mostrato che se le donne avessero lo stesso accesso alle risorse degli uomini, potrebbero coltivare dal 20 al 30% in più di cibo nelle loro fattorie e ridurre il numero di persone affamate nel mondo di 12 al 17%”.
In poche parole Gates tocca tutti gli aspetti chiave: la disparità assodata e generalizzata a più ambiti (dal diritto alla terra all’accesso alle informazioni), il bisogno di azioni che tengano conto dei bisogni specifici, e la significatività del ritorno. Cosa fare allora per continuare a colmare questo divario di genere? Se fosse semplice forse l’avremmo già fatto, e se tutti fossero d’accordo nel farlo saremmo già un pezzo avanti. C’è però una cosa che potrebbe semplificare la via e cominciare anche a aumentare il consenso: cominciare a contare e raccogliere i dati tenendo conto delle donne.
Intanto raccogliendo sempre – qualsiasi sia il tipo di indagine che si fa – i dati disaggregati per sesso (ovvero distinguendo quanti uomini e quante donne per ogni domanda e query) e mantenendo questa disaggregazione in tutti i dataset per tutto il dataset. Sembra banale ma non viene fatto quasi mai. Ma non solo. Si devono anche cominciare a raccogliere dati che riguardano le donne perché “Contare è essenziale e rivoluzionario, perché rileva immediatamente il tasso di biodiversità sociale e quindi di giustizia”, scrive Murgia. Contare e raccogliere dati sulle donne, sui loro corpi, sui loro bisogni, sui loro comportamenti, sulle loro scelte permette di fare tante cose: in primo luogo di visualizzare il divario. Quando si cominciano a raccogliere dei dati ci si rende conto di quanti ne mancavano finora; di quanto sistematicamente siano stati non raccolti e non presi in considerazione; e ci si accorge di quanti “non è vero” non si possono più dire.
Quando si raccolgono i dati, poi, questi possono essere interrogati in diversi modi: per capire e per agire. Per esempio per capire come mai si trovano proprio quei numeri, da cosa dipendono. Perché le automobili le guidano più gli uomini? Perché le donne non se le possono permettere, perché le donne prendono meno la patente, perché le donne stanno di più a casa a occuparsi della famiglia…e via a ritroso a chiedersi i perché dei perché per conoscere meglio la società e i suoi problemi. Oppure si studiano per agire: se le donne prendono meno l’auto e usano di più i mezzi pubblici, questi sono disegnati e organizzati per essere efficienti per loro? Per essere sicuri? Come si possono modificare in questo senso? Come si può fare in modo che le donne non siano costrette a restare a casa ma i compiti di assistenza siano equidistribuiti?
In un’ottica futura poi raccogliere i dati che tengano conto non solo del maschio bianco eterosessuale di circa 30 anni e 70 chili è ancora più fondamentale. Presto (già oggi) questi dati saranno dati in pasto a sistemi di intelligenza artificiale e machine learning e come recita un mantra ormai famoso, “garbage in, garbage out”. Se daremo in pasto a questi sistemi banche dati che mancano di informazioni fondamentali per metà del genere umano (ma questo è vero anche per le cosiddette minoranze, che poi non solo contano e molto, ma messe insieme fanno una maggioranza non trascurabile) otterremo risultati altrettanto monchi e parziali. Inutili nella migliore delle ipotesi, se non dannosi. E, soprattutto, continueremo a perpetuare bias e stereotipi e ad ampliare il divario e i divari. Già sta succedendo, se non agiamo subito cambiare le cose sarà ancora più difficile. Io intanto, grazie a Guido Romeo, Emanuela Grigliè e Caroline Criado-Cortez, sono pronta per il mio prossimo incontro di “bolla”.
In questo articolo ho nominato molti libri, molte persone, e ce ne sono altre che può essere utile conoscere e seguire, ve li metto tutti qui, in ordine di comparizione, così è più facile.
Michela Murgia, Stai Zitta, Giulio Einaudi editore, 2021
Emanuela Grigliè – Guido Romeo, Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design. Codice edizioni, 2021
Caroline Criado-Cortez, Invisibili, Giulio Einaudi editore 2020 (e la sua newsletter qui: http://newsletter.carolinecriadoperez.com/)
Geena Davis Institute on Gender in Media https://seejane.org/
World Economic Forum – Global Gender Gap Report 2020 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
Cristina Da Rold – https://cristinadarold.com/ (@thedatagap su instagram)
Joni Seager, L’atlante delle donne”, add editore, 2020
Bill Gates, Clima. Come evitare un disastro, Mondadori 2021



