Pubblichiamo un estratto dal volume di Armando Punzo, Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna (Luca Sossella editore). Armando Punzo è stato insignito del Leone d’oro alla carriera della Biennale teatro di Venezia 2023.
L’esperienza della Compagnia della fortezza nasce nel 1988 nel Carcere di Volterra, da un’idea di Armando Punzo, regista e direttore artistico. È la prima e più longeva esperienza di lavoro teatrale in un istituto penitenziario. In trentacinque anni di lavoro con la Fortezza ha messo in scena oltre trenta spettacoli.

Come comincia l’avventura giusta?
Comincia dalla disperazione. Quella di quando hai quasi trent’anni, non stai bene da nessuna parte, cerchi una direzione per la tua vita e non hai altra scelta che seguire un’intuizione, provare con tutte le tue forze e farcela a ogni costo, perché non c’è un’alternativa valida, non esiste, tu non la vedi. Ero giovane, volevo fare tutto ma non sapevo nulla, e non volevo neppure che qualcuno mi aiutasse a capire in che direzione andare. Io e Annet abitavamo a Mazzolla, una frazione di Volterra, in una casa in cui se nevicava ti nevicava direttamente addosso e, credimi, non era romantico.
Me lo ricordo ancora bene il freddo, la neve che passava attraverso i coppi del tetto e i rondoni che ritornavano a fare il nido in primavera. Nelle sere d’inverno, appena rientravamo a casa, accendevo la stufa a legna con Yuri, ma prima di sentire un po’ di calore ci volevano almeno due ore. Nel frattempo, il gruppo L’Avventura si era sciolto, tra l’altro in modo conflittuale, e quella fine aveva avuto un sapore amaro. Molti dei miei compagni erano migrati nei progetti di Roberto Bacci, a Pontedera. Dopo gli anni di stenti e resistenza, avevo vissuto quell’affiliazione come un grande tradimento, infatti io e Annet eravamo rimasti a Volterra, fuori da tutto.
Con un figlio appena nato e i primi tentativi da soli: A. da Agatha con Thierry Salmon, Etty, Camille Claudel, Luoghi Comuni. Avevamo chiesto al comune di poter continuare a lavorare nell’ex sede dell’associazione Il Porto, il Teatro di San Pietro, che diventò sede della nostra nuova associazione: Carte Blanche. La targa ingiallita sulla porta dell’ingresso è lì da allora, l’ho scritta io a mano. Proprio di fronte a quel teatrino c’era il carcere che avevo visto arrivando la prima volta a Volterra. Un giorno ho alzato lo sguardo e ho pensato: i detenuti non hanno niente da fare, hanno tantissimo tempo libero e nessun pensiero pregresso sul teatro, nessuna eredità. Insieme potremmo rifare tutto da capo. E così ho chiesto di entrare. Dopo meno di un mese mi hanno risposto.
Volterra era una città convintamente comunista. Grazie all’intercessione dell’assessore alla cultura Pietro Cerri, il sindaco Giovanni Brunale, lo stesso che aveva decretato la chiusura del Gruppo L’Avventura, mi aveva autorizzato a entrare. Solo dopo avrei imparato che il Granducato della Toscana è stato il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte, nel 1786: non era quindi stato un caso che il mio progetto avesse incontrato quella disponibilità del Comune di Volterra e della rossa Toscana.
Dunque, entrai. Mi avevano autorizzato a condurre un laboratorio di duecento ore, ci sono rimasto per millecinquecento.
Perché sei rimasto così tanto?
In quella stanza con una spalliera da ginnastica, il pavimento di graniglia, le sedie di plastica bianche, umidità e muffa, e un freddo, un freddo terribile, avevo trovato quello che stavo cercando, il posto giusto in cui far reagire il teatro per metterlo alla prova e la mia compagnia, la Compagnia della Fortezza. Inseguendo il teatro mi ero ritrovato in una cella, a un certo punto della mia vita, a fare un discorso in quel primo giorno, a spiegare che non mi interessava nulla del carcere, che non ero un uomo delle istituzioni, che ero un regista, volevo fare teatro, ma diverso da quello che c’era fuori, e che volevo farlo con loro. E questo era tutto. E se non erano interessati potevano dirmelo, perché sarei andato via.

E tutta questa disperazione, neanche me ne rendevo veramente conto in quel momento, aveva funzionato, e lentamente la mia determinazione a dar vita a una compagnia teatrale modellava la mia competenza in fatto di detenzione, privazioni, relazioni, pericoli, trame, politica. Ci passavo tutto il giorno, in carcere, fin da subito. D’inverno, nei primi tempi, quando eravamo veramente al limite della sussistenza e l’ufficio di Carte Blanche era freddissimo (pure quello!) perché non potevamo permetterci il riscaldamento, passavo molto tempo anche nella stanza della fotocopiatrice degli uffici del carcere, vicino alla sala degli educatori e alla direzione. Lì studiavo, facevo fotocopie, preparavo materiali.
Mi racconti quel primo giorno?
Siamo entrati, io e Annet. In guardiola hanno segnato il nostro ingresso su un registro e un agente ci ha accompagnati in una cella di tre metri per nove al piano terra, la stessa di adesso. I detenuti che si erano iscritti al laboratorio erano già scesi, ci aspettavano. Mi sono reso conto immediatamente che erano tutti napoletani, così quando li ho sentiti bisbigliare tra loro ho capito che dovevo anticipare i prevedibili commenti sulla figura femminile che mi accompagnava, dichiarandomi subito: «Song ’e Napule, capisco quello che dite». Così ci siamo intesi, senza aggiungere altro. E poi abbiamo cominciato.
Non avevo preparato niente da dire, sono andato a braccio. Mi sono presentato e ho raccontato la favola che ripeto da trent’anni, ho detto più o meno le cose che dico ancora oggi: «Sono qui perché vorrei fare teatro con voi, non mi interessa nulla della vostra storia, non sono un educatore, né uno psicologo, né un assistente sociale, vorrei creare una compagnia teatrale qui perché non mi interessa lavorare con i professionisti fuori». Ma tu capisci che in quegli anni il fatto che ci fosse uno che andasse di propria iniziativa in un carcere penale per fare teatro di ricerca potesse risultare quanto meno sospetto. Infatti, non ci credeva nessuno, né gli agenti, né i detenuti.
I primi mi pensavano infiltrato della camorra, i secondi infiltrato della polizia. Ci sono voluti un paio d’anni perché cominciassero a fidarsi. D’altronde, anche con il direttore Renzo Graziani, uomo illuminatissimo, ho cominciato a parlare davvero dopo due anni. Lui l’aveva sposata questa esperienza, era una persona difficile ma aveva una visione molto aperta. Tra l’altro a quei tempi, nel bene e nel male, i direttori potevano fare veramente il bello e il cattivo tempo, avevano un’autonomia enorme. Il Carcere di Volterra si regge ancora sul lavoro che ha organizzato lui trent’anni fa. Ha formato un gruppo di agenti che hanno fatto propria la sua idea di istituto aperto: «Meno pennacchi, meno agenti, e più società civile dentro».
Com’era composta la popolazione dei detenuti quando sei arrivato tu?
Erano gli anni dei terroristi e dei cutoliani. C’erano napoletani, siciliani, calabresi e qualche marocchino. Per mesi ho passato intere giornate a lavorare sui testi con persone che non avevano mai imparato a leggere. Mi sembrava una cosa ricchissima. Tutti i limiti diventavano sfide. Mi ero trovato davanti una situazione molto più interessante di quella che mi aspettavo. Avevo ritrovato Napoli nel cuore della Toscana, proprio io che da Napoli ero sempre scappato. E insieme a lei, adesso, c’era tutto il sud del mondo.
Partecipavano tutti al tuo laboratorio?
Solo quelli che avevano scelto di venire. Occorreva fare una ‘domandina’, esattamente come fanno oggi. Al mio arrivo, una delle educatrici mi aveva proposto di consultare i fascicoli di alcuni detenuti, perché scegliessi tra quelli secondo loro più adeguati al ‘trattamento teatrale’. In maniera del tutto intuitiva dissi categoricamente di no. Doveva essere il teatro a scegliere. E comunque non mi fidavo del fatto che a indicarmi la strada fosse una rappresentante dell’istituzione. Non ho mai fatto selezioni.
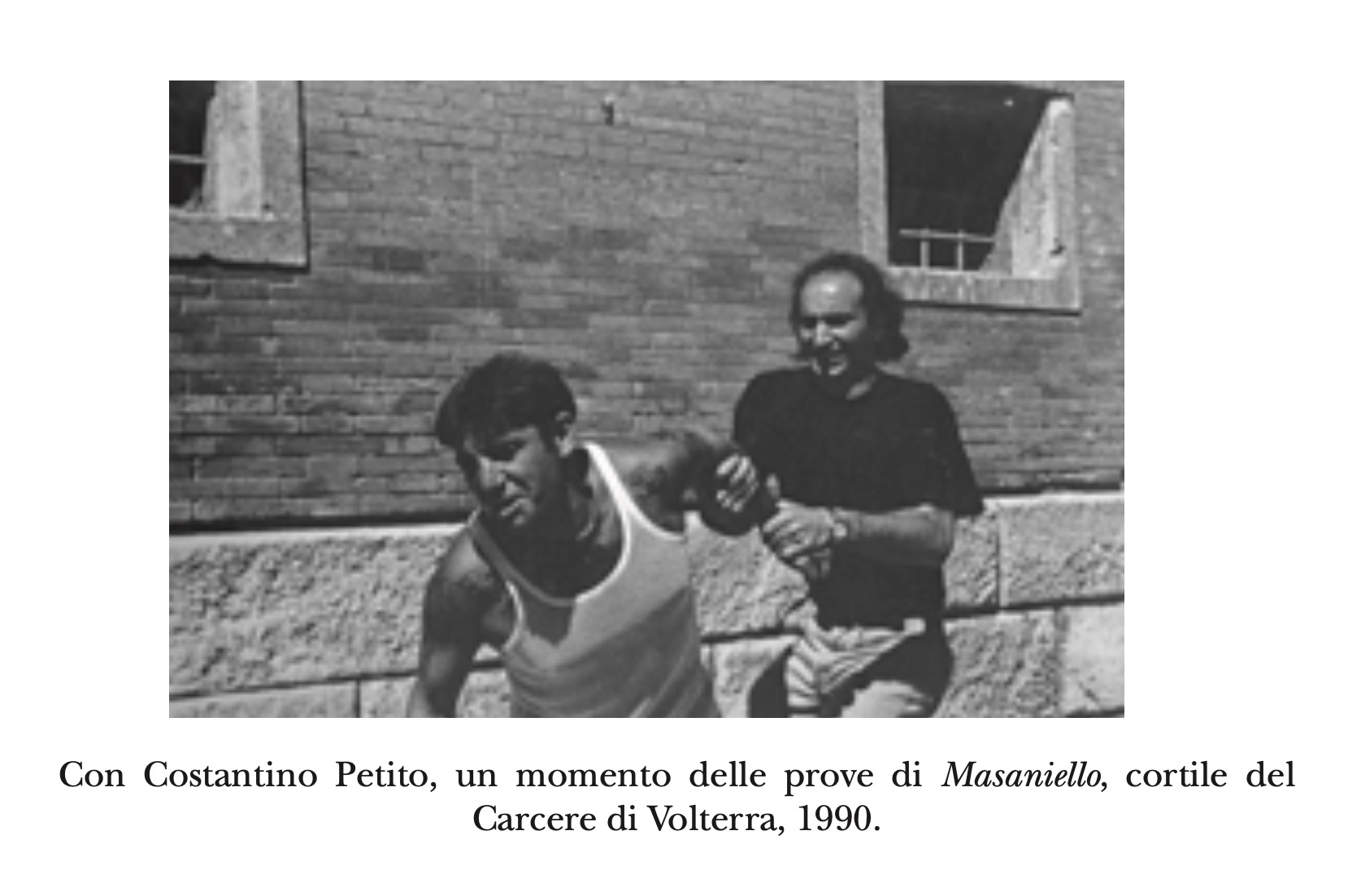
Innanzitutto perché se ci fosse stata una selezione preventiva avrei rischiato di perdere degli attori bravi – infatti proprio i meno raccomandabili si sono rivelati attori eccezionali –, e poi volevo che il teatro usasse altre logiche nel giudicare le persone. Nel primo spettacolo erano una quindicina. Molti napoletani, un cileno e un marocchino. Per calabresi e siciliani era impensabile: «Queste pagliacciate le possono fare solo i napoletani», dicevano. Poi si sono avvicinati tutti e il numero è cresciuto moltissimo e velocemente. Oggi sono circa ottanta.
Immagine di copertina: foto Stefano Vaja Naturae La valle della permanenza IV quadro


