Il re è nudo, l’epidemia ha squarciato il velo sulle nostre vulnerabilità strutturali. E siamo di fronte a un bivio cruciale, sostiene Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis e autore de Il contagio del desiderio. Statistiche e filosofia per capire il nuovo disordine mondiale (Ponte Alle Grazie): da una parte il rischio di un «possibile slittamento lessicale», con le categorie cliniche dei “contagiati” e degli “immuni” che diventano paradigma politico, traducendosi in diffidenza permanente, alimentando paura, rabbia, rancore.
Dall’altra il contagio del desiderio, «che è sempre desiderio dell’altro». Come spiegava Alexandre Kojève, il filosofo che «come una cometa aveva attraversato la Mosca zarista e poi rivoluzionaria, la Heidelberg tempio sacro della filosofia tedesca, la Berlino decadente della Repubblica di Weimar minacciata dal nazismo, la Parigi dei caffè degli esistenzialisti e la Parigi occupata, per poi concludere la sua esistenza nella Bruxelles sede del potere tecnocratico europeo». L’uomo che ha lasciato «un segno indelebile nel pensiero del Novecento» e che, sostiene Valerii, può aiutarci a comprendere anche i nostri tempi incerti.
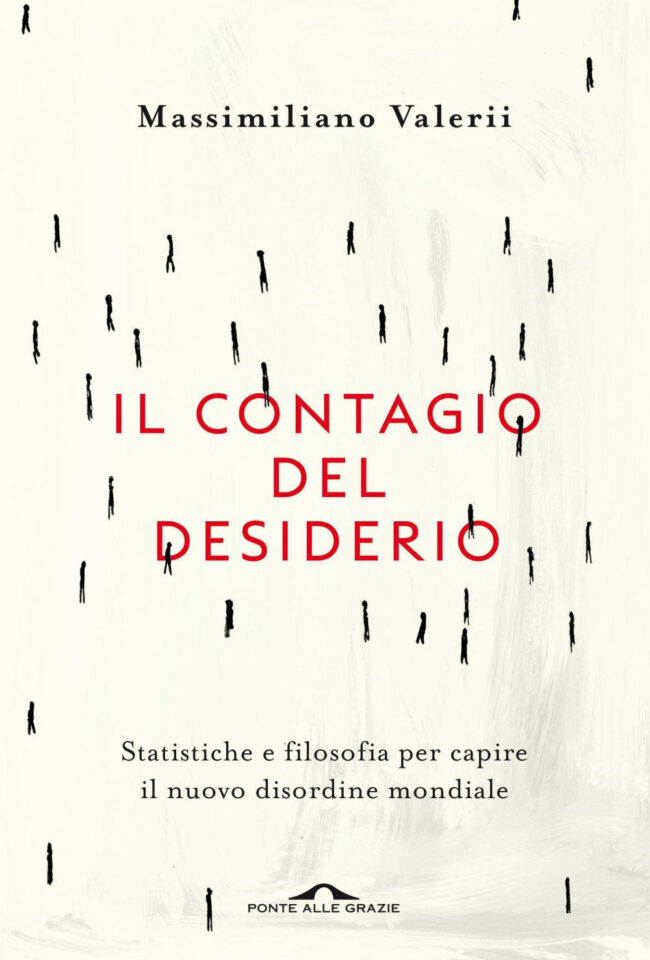
Per affrontare le inquietudini e i cambiamenti del nostro tempo, nel suo libro lei adotta una formula curiosa, combinando filosofia e scienze sociali, statistiche, economiche, demografiche. E decide di cominciare con un giallo, un mistero che riguarda Jacques Lacan, la visita che fece un giorno d’inizio giugno del 1968 alla casa di Kojève, da poco defunto, e un manoscritto scomparso. Ma perché oggi dovremmo ancora occuparci di Kojève, il filosofo che «aveva fatto convolare a nozze, in maniera del tutto originale, la filosofia di Hegel, il marxismo e l’esistenzialismo di Heidegger»? E perché, qui come nel suo precedente libro, La notte di un’epoca (Ponte Alle Grazie), ha scelto di coniugare filosofia e statistiche?
Perché per capire quello che ci sta succedendo non è più sufficiente un approccio esclusivamente economico, sociale o giuridico. Ha bisogno di un pensiero diverso anche chi, come me, per mestiere si occupa tutti i giorni di scrutare i dati. Con una battuta potremmo dire che «non di solo pane vive l’uomo». Faccio un esempio: come spiegarsi l’inquietudine che oggi provano anche i ceti sociali abbienti, non disagiati, che non avrebbero motivi validi per temere declassamenti? L’economia, da sola, non riesce a spiegarlo. Io cerco di rispondere a queste ed altre domande ricorrendo all’aiuto dei classici del pensiero filosofico.
Lei ha fatto riferimento al giallo, al mistero del manoscritto scomparso. In effetti ci troviamo davvero di fronte a un enigma da svelare. Il recente rapporto del Censis coincide con l’anno della paura nera, con l’insopportabile presenza della morte e del dolore in una società che considerava un diritto sociale acquisito l’allungamento della speranza di vita, in buona salute. C’è dunque una lettura congiunturale. Ma già negli anni scorsi abbiamo parlato di società del rancore, di sovranismo psichico. Anche dentro questa congiuntura c’è dunque un enigma da sciogliere. Dobbiamo spiegare la nostra inquietudine.
È qui che entra in gioco Kojève, il quale negli anni Trenta, durante il suo seminario all’École pratique des hautes études di Parigi sulla Fenomenologia dello spirito di Hegel, ha coniato la teoria sulla «fine della storia», che poi avrebbe trovato una nuova vita grazie al celebre libro di Francis Fukuyama del 1992, La fine della storia e l’ultimo uomo. Nel ciclo storico che corrisponde agli ultimi 30 anni, diciamo dall’abbattimento del muro di Berlino in avanti, ci siamo convinti che la storia fosse finita nell’accezione di Fukuyama, ci siamo persuasi di assistere al trionfo assoluto del capitalismo e delle democrazie liberali. Questa convinzione ci ha accompagnato per molti anni. Penso all’ultimo libro di Branko Milanovic, il cui titolo originale suona così, Capitalism Alone (tradotto in italiano come Capitalismo contro capitalismo, nda): «alone» in una doppia accezione, perché il capitalismo sembrava segnare la fine della storia e perché ha finito per farci sentire molto soli. Un titolo paradigmatico.
Oggi scopriamo che questo ciclo trentennale di «fine della storia» ha portato con sé qualcosa di cui non avevamo tenuto conto e di cui, nelle società occidentali, paghiamo il prezzo. È avvenuto quel che aveva previsto Kojève, un riequilibrio planetario degli squilibri storici, sociali ed economici tra le varie regioni e Paesi del mondo. Il caso della Cina è emblematico, ma ci sono tanti altri esempi che incarnano questo riequilibrio, che in certi casi è un vero e proprio sorpasso. Per dirla con una battuta, il baricentro del mondo si sta spostando dall’Atlantico al Pacifico. Un evento che per noi si traduce nel crepuscolo di quel mondo che abbiamo conosciuto e che era basato sulla supremazia economica, tecnologica e militare dell’Occidente. Oggi nelle nostre coscienze c’è la segreta paura che prima o poi qualcuno arrivi e ci tolga dal piedistallo, che prenda il nostro posto sul palco della storia.
Si spiegano così anche quegli appelli politici – come il «Make America Great Again», o il «prima gli italiani» – di chi ha saputo interpretare l’inquietudine di fronte a un nuovo ordine mondiale che, visto con i nostri occhi, si configura come nuovo disordine mondiale. Da qui anche il ritorno all’ideologia nazionalista, ai confini chiusi, alle frontiere impermeabili, avvenimenti che sconfessano l’idea, dominante negli ultimi 30 anni, di una fine della storia e della definitiva affermazione di una società aperta, liberale e liberista.
Una società che lo stesso Kojève, definito «il Flaubert della diplomazia internazionale», avrebbe contribuito a edificare nella seconda parte della sua vita, «nel ruolo tecnico-politico di conseiller du prince». Ma prima di arrivare al Kojève funzionario del governo francese, vorrei restare sulle due teorie di Kojève su cui lei articola Il contagio del desiderio: la «fine della storia», appunto, ma anche il desiderio di riconoscimento, che «rende l’uomo inquieto, lo spinge all’azione» e dà inizio alla storia, sosteneva Kojève. E che può avere fine solo nell’affermazione progressiva di uno «Stato universale e omogeneo», organizzato in una società senza classi, formata da individui post-storici sottratti alla logica del desiderio di riconoscimento. Il desiderio di riconoscimento sociale di cui parlava Kojève cosa dice del presente?
Secondo la rilettura di Kojève della Fenomenologia dello spirito di Hegel, il desiderio di riconoscimento è la molla che mette in moto la storia, che segna la storia millenaria della civiltà umana, che si traduce in guerre, conflitti, spargimenti di sangue fino a quando, secondo una visione teleologica, non arriva il riconoscimento sociale di ciascun individuo. Quando ciò avviene, la storia si compie. Kojève all’inizio sosteneva che ciò fosse avvenuto con la rivoluzione francese, con i due grandi interpreti dell’epoca, Hegel sul piano filosofico, Napoleone sul piano concreto e giuridico, con l’introduzione del codice napoleonico. Poi ha posticipato la «fine della storia» alla rivoluzione d’Ottobre e a Stalin, fino ad arrivare a un’ulteriore postdatazione: sosteneva che coincidesse con l’affermazione dell’American way of life e del capitalismo fordista, che dava piena soddisfazione a tutti gli individui sul piano materiale, con il consumismo, ma anche sul piano sociale, facendo nascere e stratificare una forte classe media.
Ognuno di noi, sostiene Kojève, ha il desiderio di essere riconosciuto dall’altro. Una tesi che verrà poi ripresa da Lacan sul piano psicanalitico, da René Girard sul piano antropologico e da molti altri epigoni. E che trova riscontro anche in Italia. Se pensiamo alla storia sociale del nostro Paese, all’evoluzione dal dopoguerra in poi – la ricostruzione, il miracolo economico degli anni Cinquanta e Sessanta, la crescita esplosiva degli anni Settanta e via dicendo – ci accorgiamo che la traiettoria di crescita economica si è coniugata con una parabola di inclusione sociale, con la stratificazione di quel grande ceto medio in cui ciascuno trovava una forma di riconoscimento, una legittimazione sociale.
Il desiderio di riconoscimento è dunque per Kojève la molla della storia. Ma lo ritroviamo anche sul piano individuale. Facendo un volo pindarico, trasponendo questa lettura nelle nostre vite quotidiane immerse nei social network, notiamo che la ricerca continua del riscontro nei feedback, nelle citazioni, nei like non è altro che un desiderio di riconoscimento. Sul piano dell’analisi sociale, economica e politica, la lettura di Kojève come abbiamo visto spiega la globalizzazione moderna, almeno in parte. Perché qualcosa è andato storto, dal nostro particolare punto di vista: il baricentro del mondo si sta spostando e lascia le società occidentali, specie quelle europee, nelle retrovie. Quell’idea di fine della storia caratterizzata da una crescete armonizzazione a livello mondiale oggi viene confutata dai fatti. Gli ultimi trent’anni hanno ravvicinato l’umanità, ma i prossimi trenta ci allontaneranno.
Il punto più interessante della sua analisi, mi pare, è legato ancora una volta al desiderio. Lei sostiene che «il canone occidentale del desiderio è finito in un cono d’ombra», che «la globalizzazione, da promessa di nuove opportunità di benessere per tutti, ora evoca uno spettro: il fantasma di un declassamento economico e sociale». Quali sono le conseguenze di questa «morsa micidiale» tra passato e futuro, sulle spalle «l’eredità inaspettata dei tre decenni di “fine della storia”» e di fronte «la prospettiva di un’annunciata esclusione dal palco della storia nei prossimi tre decenni»?
A questa dinamica va ricondotta l’evoluzione, o involuzione, dell’ultimo ciclo politico, a cui abbiamo dato nomi come sovranismo e populismo, così come gli appelli identitari, gli slogan come «Make America Great Again». Quell’«again» è emblematico: l’idea di dover tornare a essere un grande Paese risponde ai timori di non poterlo più essere neanche in futuro. È come se venisse a mancare la terra sotto i piedi. In passato ho usato concetti come sovranismo psichico: prima che politico, infatti, è un modo di pensare, un sentimento, è presente nel cuore e nella testa delle persone. Sarebbe superficiale credere che i leader politici siano semplici fomentatori della piazza. In realtà incassano consenso perché interpretano sentimenti diffusi, anche negli strati benestanti della società, tra coloro che non hanno reali timori economici. Questo la dice lunga: c’è un’importante componente identitaria che sentiamo minacciata, perché se siamo “scavalcati” non siamo più riconosciuti per quei privilegi e traguardi per i quali le generazioni precedenti hanno faticato. Ecco perché oggi il nostro desiderio è finito in un cono d’ombra. Il rancore deriva dal fatto che si sono bloccati i processi di mobilità sociale, l’ascensore sociale si è fermato, il patto intergenerazionale che aveva funzionato dal dopoguerra in avanti si è interrotto. I giovani sono i primi nella storia recente a essere destinati a un futuro peggiore rispetto ai genitori. Un evento senza precedenti. Ciò alimenta l’inquietudine, il rancore per una tacita promessa che si avverte non poter più essere mantenuta.
E poi c’è un altro aspetto, cruciale: quello demografico. Sono convinto che chi riuscirà a capire perché gli italiani hanno smesso di fare figli avrà decifrato il segreto della nostra società. Nell’ultimo anno abbiamo registrato 420.000 nati, il minimo storico da quando possediamo statistiche affidabili, in pratica dall’unità d’Italia. Perfino durante la seconda guerra mondiale si facevano più figli rispetto a oggi. Anno dopo anno conquistiamo nuovi record al ribasso. Già sappiamo che, a causa della recessione economica, nel 2020 sprofonderemo sotto la soglia di 400.000 nuovi nati, con un altro record negativo. Come spiegarlo? Perché si fanno così pochi figli? Naturalmente ci sono delle ragioni economiche, ma non spiegano tutto. Il punto è che il desiderio della procreazione è finito anch’esso in un cono d’ombra. C’è l’idea che le prospettive future siano talmente incerte da sfuggire al nostro controllo. La sensazione che il futuro non dipenda da noi. Siamo ben oltre la razionalità economica, ben oltre le lamentele sul ceto politico di piccolo cabotaggio, sull’assenza di misure di sostegno. C’è una sorta di minaccia identitaria, nel senso profondo del termine, che ci fa percepire che qualcuno ci sta scalzando dal piedistallo del benessere, qualcuno che prende il nostro posto sul palco della storia. Sembrano considerazioni astratte, ma incidono fortemente nell’inconscio collettivo. Il motivo per cui non si fanno figli ha a che fa con questo inconscio.
Nell’ultimo rapporto Censis viene descritto «l’inverno demografico che sta progressivamente rimpicciolendo il Paese». Nel suo libro insiste sulla questione: «la prima variabile correlata al peso economico e politico di un paese sul piano internazionale è proprio il suo peso demografico». Scrive inoltre che è «il cambiamento più importante, a cui è appeso il nostro futuro», presenta dati allarmanti sulla flessione demografica, «che suonano come la tromba dell’apocalisse» annunciando una catastrofe con ripercussioni sul piano sociale. «L’Italia e il resto del mondo vanno in direzioni opposte e la forbice si allarga anno dopo anno», ma il problema «nessuno vuole vederlo, pochi ne parlano». Perché? Forse perché ha a che fare con questioni delicate come l’identità collettiva, la percepita minaccia identitaria, la necessità di riconoscere che abbiamo bisogno degli altri? O cos’altro?
Per diverse ragioni, ma innanzitutto perché c’è un’offerta politica orientata all’incasso del consenso nell’immediato. La questione della transizione demografica richiederebbe un approccio diverso, di lungo termine, ma ci siamo assuefatti a una politica di piccolo cabotaggio, come se fosse un destino. Eppure sono convinto che se un giorno si presentasse un’offerta politica di segno diverso, che proponesse un ragionamento di prospettiva, sulla società che vogliamo essere da qui ai prossimi decenni, verrebbe premiata.

L’altro motivo di questa scandalosa rimozione è che la questione tocca corde delicate, che fanno male. Il modello previsionale dell’Eurostat ci dice che da qui ai prossimi trent’anni la popolazione italiana diminuirà di 4,5 milioni, come se città come Milano e Roma scomparissero in tre decenni. Tutto questo si traduce in una contrazione dell’economia. Nel libro noto per esempio che, secondo il centro studi della Banca d’Italia, nel 2050 la perdita cumulata del Pil italiano per il calo della natalità sarebbe del 20 per cento. Un tema talmente doloroso e difficile da affrontare che si preferisce distogliere lo sguardo. Abbiamo anche un problema di leadership. Se è vero che è leader chi guarda sopra le teste degli altri, alla linea dell’orizzonte, allora oggi nella classe politica non ce ne se sono.
Come scrivete nel rapporto del Censis, siamo «privi di un Churchill a fare da guida nell’ora più buia». Ma allo stesso tempo registrate che il 48% degli italiani desidera «un uomo forte al potere che non debba preoccuparsi di Parlamento e elezioni». Come interpretare questo dato? Quanto ha a che fare con il fatto che «le moderne democrazie liberali stanno perdendo la capacità di rispondere ai bisogni sociali»? L’esclusione dal contratto sociale favorisce l’invocazione dell’uomo forte?
È un meccanismo piuttosto collaudato. Nel momento del massimo pericolo le popolazioni in crisi, smarrite, cercano risposte securitarie. Quest’anno in particolare gli italiani hanno percepito lo Stato come un salvagente a cui aggrapparsi, grazie alla politica dei bonus, dei sussidi, dei ristori, che ci hanno consentito di guadagnare una certa pace sociale. Ma contrariamente a quel che si può credere è proprio nel momento di massimo spaesamento che le popolazioni consumano più immaginario. «Non di solo pane vive l’uomo», dicevamo all’inizio. Quando manca il pane, nel senso metaforico, quando non c’è una cornice di senso forte, rassicurante, tendiamo a consumare più immaginario. L’affidamento all’uomo forte deriva dal fatto che le popolazioni hanno bisogno di nutrire non solo la pancia, con il pane, ma anche il proprio immaginario.
Viviamo un momento di instabilità. Nel discorso pubblico ha cominciato a prendere piede un’espressione apparentemente contraddittoria come democrazia illiberale. In questo scorcio di storia le democrazia liberali non soddisfano più i bisogni sociali, i processi di mobilità sono fermi, le prospettive dei giovani sono peggiori rispetto a quelle dei genitori: è un mondo rovesciato. E Donald Trump, che ha comunque raccolto più di 70 milioni di voti, lo ha capito. Tanto è vero che, ricordo nel libro, la politica statunitense vive un paradosso: Trump appartiene a quello stesso partito repubblicano, liberale e liberista, a cui apparteneva quel Donald Reagan che più di 30 anni fa invitava Gorbacev ad abbattere il muro di Berlino ed aprire le economie dei Paesi socialisti al resto del mondo. Era l’inizio del lungo ciclo di globalizzazione accelerata. Mentre oggi Trump fa rientrare nella politica i dazi internazionali, l’opposto rispetto alla ricetta classica del partito repubblicano. È questo rovesciamento che ci inquieta. È la fine di un’epoca. E l’incertezza sul ruolo che occuperemo in questa nuova epoca produce scossoni politici, sociali ed economici.
Ironie della storia: Trump versus Kojève, che tanto si era adoperato, come funzionario della diplomazia economica francese, per istituire un sistema di regole internazionali che facesse cadere i dazi. Ma occupiamoci del futuro, delle scorie della pandemia. Lei sostiene che forse la pandemia ci lascerà «in eredità una permanente tensione collettiva all’immunizzazione da ogni rischio rappresentato dall’“altro”». E mette in guardia da un «possibile slittamento lessicale. Le categorie cliniche dei “contagiati” e degli “immuni” possono rimanerci appiccicate», tradursi in diffidenza permanente. Privi della teleologia rassicurante di Kojève, in un presente senza prospettiva e senza mobilità sociale, rischiamo davvero di finire in una «spirale regressiva» in cui ribollono «le emozioni più elementari come paura, rabbia, rancore»? Le categorie epidemiologiche diventeranno paradigma politico?
Il rischio c’è. Avrà visto che all’inizio della pandemia si dibatteva sull’eventuale rivisitazione del modello della globalizzazione in chiave regionalista, mentre il settimanale The Economist a maggio titolava Goodbye globalisation. Kojève è affascinante perché era convinto che la «fine della storia», concetto acquisito a livello filosofico, andasse messo in atto a livello pratico, attraverso la diplomazia internazionale. Così, si impegnò in prima persona per i Trattati del 1957 che istituirono la Comunità europea e per i primi accordi internazionali per la liberalizzazione dei commerci. Era convinto di mettere in pratica la sua filosofia. Oggi però lo shock della pandemia accelera i processi preesistenti, così come la percezione e la consapevolezza che qualcosa è andato storto. E porta con sé il rischio che le società si chiudano in se stesse.
Se ci guardiamo intorno, notiamo da una parte un nuovo corso a Bruxelles, una nuova idea di Unione europea, con la sospensione del patto di stabilità, con i prestiti per la ricostruzione da parte della Banca centrale europea. Sono segnali, parziali, che l’Europa ha capito che occorre cambiare marcia, rinunciando all’Europa degli egoismi e dei veti incrociati. Ma c’è anche un continuo rimpallo di responsabilità, per esempio con la Cina a proposito dell’origine del virus, che dimostra l’aumento della diffidenza. Sono segnali che vanno in direzione contraria rispetto all’idea di uno Stato mondiale. Storicamente, gli Stati-nazione sono un accidente. È quasi scontato pensare a un’evoluzione verso uno Stato mondiale, transnazionale, che rifletta un’unica comunità umana. Ma ci sono resistenze identitarie che ci portano a distanziarci dall’“altro”. Non sappiamo quale sarà il futuro dell’Unione europea. La Brexit rappresenta il naufragio della narrazione dell’Europa comune come destino. Oggi forse a Bruxelles si apre un nuovo corso, a Washington sta per insediarsi un nuovo presidente da mettere alla prova. Ma ci sono nuovi attori che giocano ruoli fondamentali nel nuovo ordine mondiale. Noi, che ruolo giocheremo?
Vedremo se si tratta davvero di un nuovo corso europeo e se sarà sufficiente a modificare le percezioni degli italiani: secondo il rapporto Censis «solo il 28% degli italiani nutre fiducia nelle istituzioni comunitarie, a fronte di una media Ue del 43%». Un dato che ci restituisce solo una parte del «sistema-Italia», questa «ruota quadrata che non gira». In un Paese «spaventato, dolente, indeciso tra risentimento e speranza», in un contesto in cui ci si affida alle risposte individualizzate per risolvere problemi sistemici, quali forme di socialità politica, di partecipazione e collaborazione sono possibili? Cosa aspettarsi?
In questi mesi si è spesa tanta retorica sul fatto che non saremo più come prima, che la pandemia ci cambierà. Io invece credo che il vero rischio da cui guardarci sia rimanere quelli di sempre. Lo si vede nella rissosità della politica, nei conflitti inter-istituzionali tra Stato e regioni. Ci chiediamo come spenderemo i circa 200 miliardi del Recovery fund, ma ci siamo anche accorti che forse non saremo in grado di farlo, come avvenuto in passato. La epidemia ha squarciato il velo sulle nostre vulnerabilità strutturali. Il re è nudo, non ci sono più alibi per nessuno. Che si tratti di sanità, scuola, mercato del lavoro, in ogni ambito l’epidemia ha squarciato il velo su fragilità preesistenti.
Storicamente dopo le grandi sciagure e i grandi shock, in seguito alle epidemie così come dopo l’ultimo conflitto mondiale, si sono innescati dei cambiamenti, anche sul piano tecnologico, e a volte positivi. Ma dobbiamo rinunciare alla retorica dell’attesa di tempi radiosi. Siamo di fronte a un bivio. Il velo è squarciato, non ci sono più alibi per nessuno, la presa d’atto della nostra vulnerabilità fa parte della coscienza collettiva: auguriamoci che sia l’occasione per voltare pagina. Il rischio da cui guardarsi è quel che diceva lei, che questa esperienza ci lasci in eredità un residuo malefico di diffidenza rispetto all’altro, rispetto alle altre società. L’epidemia ci dimostra che la comunità umana è una e che alcune questioni vanno gestite su scala globale, il ritorno al nazionalismo protettivo è fuori dalla storia. Ma sarà da vedere se prevarrà la dimensione emotiva della difesa identitaria o se invece sapremo farci guidare dal desiderio. Che in fondo – spiegava Kojève – è sempre desiderio dell’altro.


