“La cosa che mi fa più incazzare è lo sminuimento del ruolo intellettuale del designer.” Così mi fa l’amico, mentre ascoltiamo reciprocamente i nostri angosciosi sfoghi gonfi di partite IVA, freelancing e contratti a breve termine. E a quel punto mi chiedo in cosa consista questo ruolo, se sia effettivamente esisito, in che modo si sia estinto e cosa l’abbia sostituito. Provando a rispondere a queste domande, vorrei concentrarmi sul graphic design poiché è l’ambito da cui provengo e rappresenta a mio parere un caso paradigmatico all’interno delle cosiddette industrie creative.

In questi giorni si sente parlare molto di gig economy, l’economia dei “lavoretti”. Piattaforme come Uber, AirBnB o Foodora stanno in fretta diventando i diretti intermediari, inevitabili in quanto tendenti al monopolio, di qualsiasi tipo di servizio. Il graphic design non fa eccezione: marketplace online come Fiverr e TaskRabbit offrono accesso a progettisti grafici in grado di realizzare un logo, un sito web, una locandina.

Su Fiverr, il cui motto è “non limitarti a sognare, fai”, un logo costa tra i cinque e i nove dollari, lo stesso vale per un’infografica o un’illustrazione. Su TaskRabbit (“sbrighiamo noi le faccende, tu vivi la tua vita”) le tariffe orarie sembrano oscillare tra i 20 e i 60 dollari l’ora. La descrizione di una tasker mi colpisce particolarmente: Barbara J., 25 dollari l’ora, dichiara di aver imparato a fare grafica autonomamente, dato che tutti i suoi precedenti lavori includevano compiti grafici. Questa generalizzazione del graphic design rappresenta la chiave di volta del mio discorso sul suo potenziale ruolo intellettuale.
Automazione, defaultismo e cultura del template
Leggendo i recenti titoli dei giornali, parrebbe di essere stati teletrasportati negli anni ’30, periodo in cui John Maynard Keynes, economista di tutto rispetto, poteva affermare senza il minimo tentennamento che in breve tempo le ore settimanali impiegate nel lavoro sarebbero calate a quindici. Tale pronostico rappresenta una vivida espressione dello spirito del tempo, intriso di fiducia nell’avvento della “società del tempo libero”. A permettere la riduzione degli orari di lavoro sarebbero state le macchine, che fedelmente avrebbero automatizzato un crescente numero di processi.

Il futuro è adesso
Oggigiorno, l’hype intorno all’automazione è tornato ai massimi storici grazie soprattutto ai progressi nell’ambito dell’intelligenza artificiale e ad un ultracitato studio del 2013 secondo cui il 47% dei mestieri attualmente svolti negli Stati Uniti è a rischio computerizzazione. Lo studio include una classifica di circa 700 professioni ordinate per probabilità di automazione in ordine crescente. Il graphic design è al 161esimo posto. Non male, dai.

Bot or not?
Tuttavia, ritengo che il graphic design (in cui includo il web design), abbia già subito i drastici effetti dell’automazione, almeno in senso lato. La Rete è piena di generatori in grado di produrre infinite permutazioni di loghi. Alcuni di questi generatori fanno uso di neural network e hanno dunque la capacità di “imparare” dai propri errori. Ma non c’è bisogno di scomodare Singolarità e compagnia bella per rendersi conto del rivoluzionario impatto della tecnologia digitale sul graphic design. Nei primi anni ’90 una serie di software grafici utilizzabili sia da professionisti che da gente comune ha trovato enorme diffusione. Qualche anno dopo “photoshoppare” è diventato un vero e proprio verbo e, assieme ad altri elementi del pacchetto Adobe, ha contribuito a popolare l’immaginario collettivo. Le dichiarazioni dei progettisti che per primi si sono ispirati al digitale sono piene di entusiasmo: “Siamo i primitivi di una nuova era tecnologica”, proclama il duo Emigre, non tenendo conto che lo sono anche tutti gli altri. A guardare i loro lavori, così pieni di errori rivendicati con orgoglio, sembra però di percepire una forma passivo-aggressiva di luddismo.

April Greiman (1986)
Nel suo romanzo dalle tinte distopiche intitolato Piano meccanico (1952), Kurt Vonnegut descrive una società quasi completamente automatizzata in cui basta registrare i movimenti di un operaio su un disco per poi far sì che la macchina li ripeta con precisione all’infinito. Quando apro Word o InDesign mi imbatto in una situazione simile, dato che sul foglio, solo apparentemente bianco, sono già presenti delle scelte progettuali registrate a priori, come ad esempio l’ampiezza dei margini.

Daniel Eatock (1998)
È così che prende vita la cultura del template, in cui ogni nuovo progetto in realtà muove da una lunga serie di progetti precedenti. A metà degli anni 2000, i settaggi di default sono diventati di moda. Perché compiere delle scelte progettuali quando si può celebrare l’aprioristica purezza del template? Non siamo come nani sulle spalle di giganti? Ecco, credo che non ci possa essere espressione più autentica della spinta idealista che permea l’ideologia modernista; come tutti sanno, less is more. Il designer britannico Daniel Eatock ironizzava su questa tendenza producendo un poster generico utilizzabile per qualsiasi tipo di evento. In tal modo, proprio come accade in Piano meccanico, Eatock non aveva fatto altro che rendersi obsoleto.
Appropriazione, vernacolo e relativismo visuale
Niente più regole. Così si intitola lo studio di Rick Poynor sull’influsso del pensiero postmodernista sul graphic design. Durante il periodo in analisi, che va dai primi anni ’80 ai primi anni 2000, i designer sovvertono, una per una, tutte le regole che fino a poco tempo prima apparivano scolpite nella pietra. Con un carattere senza grazie, ovviamente.

Peter Saville (1981)
Tra le diverse tendenze che caratterizzano quest’epoca ce n’è una che mi interessa particolarmente e ha a che fare con l’appropriazione. Per capire di cosa sto parlando basta dare un’occhiata alla cover di The Man-Machine dei Kraftwerk, a dir poco ispirata al costruttivismo russo, o al lavoro di Peter Saville, il quale “clona” un poster futurista di Fortunato Depero per una cover dei New Order. Siamo nel 1981 o nel 1932? Nessuna speranza di progresso, solo un eterno ritorno all’origine.

Tibor Kalman (1987)
Qualche anno dopo, Tibor Kalman rivolge lo sguardo alle culture visuali “basse”, vernacolari, con una mossa analoga a quella compiuta in architettura da Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour. È giunta l’ora di imparare da Las Vegas, ma anche dall’insegna del supermercato o dal menu della tavola calda. Ci si concentra allora sul “design senza designer”, come recita l’invito di un evento condotto appunto dallo stesso Kalman.

Manuel Buerger (2009)
La fascinazione nei confronti della grafica di tutti i giorni, insieme ai rimpalli storici di un numero sempre maggiore di progettisti, hanno privato la grafica di qualsiasi punto fermo. A distanza di qualche anno però le regole sono tornate con vigore. Non a caso, molti grafici che hanno vissuto il periodo postmoderno lo considerano una sorta di medioevo del graphic design. Tuttavia il germe del dubbio non è stato mai del tutto estirpato e il relativismo visuale che ne consegue è una presenza costante nella pratica odierna. Come nel caso del grafico tedesco Manuel Buerger, il quale si reca in un copy shop di Mumbai per farsi progettare il suo biglietto da visita personale.
Intellettualizzazione: il designer scrittore
Forse in parte a causa di questo relativismo visuale e della democratizzazione degli strumenti, il graphic design, almeno quello prodotto nelle scuole d’avanguardia, ha avviato un processo di intellettualizzazione. Con questo termine intendo la tendenza a fare della scrittura e della ricerca il centro della propria pratica. Ovviamente, il fatto che un graphic designer produca dei testi non rappresenta certo una novità: nel 1963 Garland scriveva il manifesto First Things First mentre nel 1978 Albe Steiner pubblicava Il mestiere di grafico.
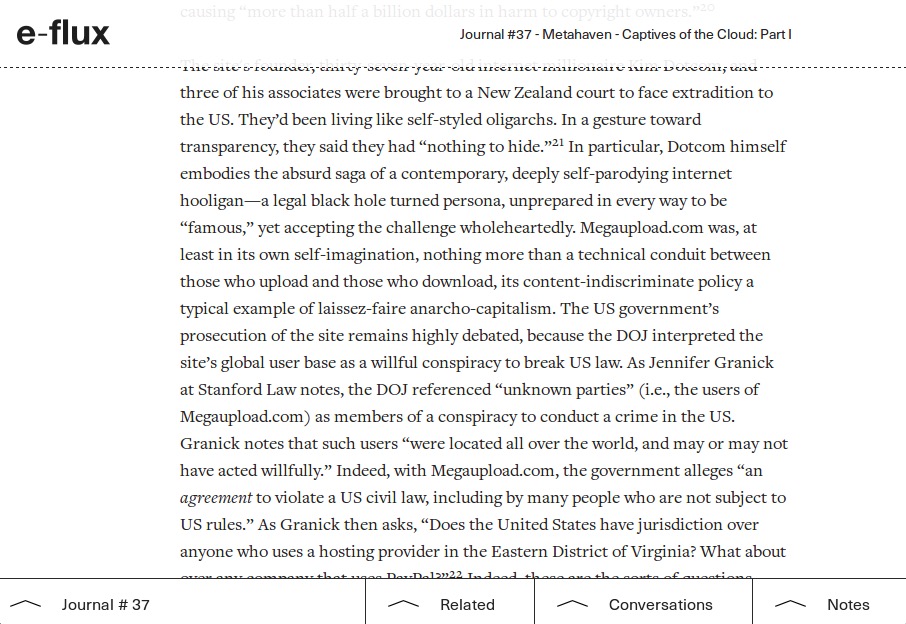
Un saggio dello studio olandese Metahaven (2012)
Il cambiamento che rilevo riguarda una certa insufficienza del visuale. Mentre i testi prodotti da Steiner o Garland agivano in un modo o nell’altro come supporto alla loro pratica progettuale, i nuovi designer svolgono ricerche practice-based, che spesso consistono nella stesura di un testo e solo successivamente nella progettazione dell’artefatto che lo ospiterà (magari affidata a un altro designer), concentrandosi a volte principalmente sulla distribuzione. E così molti designer si allontanano pian piano dal fare graphic design per come lo si intende comunemente; designer che diventano principalmente scrittori.
Il design diluito
In seguito agli sviluppi che ho descritto, la cultura del graphic design, almeno superficialmente, è diventata parte della cultura popolare. Tutti sanno che il Comic Sans, carattere vernacolare per eccellenza, è motivo di dileggio. Il graphic design intellettualizzato, in cui si scrive di più e si impagina meno, resta invece il più delle volte dominio di un grappolo di scuole illuminate e di qualche galleria d’arte. In questo caso, il ruolo intellettuale del designer viene riconosciuto soltanto da altri designer. Le eccezioni non mancano, ma sono appunto eccezioni che confermano la generale insostenibilità di questo tipo di pratica.
Oltre a essere parte della cultura popolare, il graphic design è diventato una pratica comune, come nel caso della nostra tasker che, magari tra un foglio Excel e l’altro, si sarà trovata a dover impaginare una presentazione o buttar giù un logo. Secondo Ian Bogost, saremmo tutti “iperimpiegati”. Invece di praticare soltanto la professione che ci compete, ne svolgeremmo una miriade, prima, durante e dopo l’orario di lavoro. Mansioni quali gestire il proprio personal brand online, organizzare il proprio calendario, resettare la propria password. Molte di queste includono operazioni di graphic design. Dunque, se per design consideriamo –e io credo che sia doveroso farlo– la sostituzione di un’immagine di copertina su Facebook o l’adozione di un template per il proprio blog, la progettazione grafica acquista improvvisamente lo stesso valore professionale e culturale dell’invio di una mail. In un episodio dell’Età dell’oro, webserie sulle fatiche di un gruppo di creativi milanesi, vediamo l’art director rivolgersi al grafico con un perpetuo “due punti a destra, no no, due punti a sinistra”. Il graphic design diventa anche micromanagement, mentre il designer si tramuta kafkianamente in un mouse a controllo vocale.
In pochi, dopo un master in graphic design dietro l’altro, se la sentirebbero di avallare tale prospettiva, specialmente in Italia, paese in cui la nostalgia per i tempi d’oro della “grafica di pubblica utilità” è ancora forte. Un’epoca in cui i progettisti grafici potevano dedicarsi a grandi opere e dunque costruire, affermare e infine difendere il proprio ruolo direttamente e indirettamente culturale. Un’altra ragione per cui credo che quel periodo storico sia particolarmente rilevante per i designer contemporanei è che ha prodotto una serie di ideali, di nuovo legati in un modo o nell’altro al modernismo, facili da sposare poiché universali, puri, non inquinati da fastidiose ambiguità o contraddizioni.

Genera la moda
Prima dell’avvento di TaskRabbit, i graphic designer italiani erano già attivi nella difesa della propria posizione professionale e culturale. Il campo di battaglia era quello dei concorsi non pagati, come quelli gestiti dal sito Zooppa. Una delle tattiche principali, oggi come allora, consisteva nel ridicolizzare l’assenza di buon senso del “cugino” di turno, il quale, povero sciocco, era colpevole di aver allineato il testo a destra o simili. Ed è proprio il buon senso la bomba a orologeria in seno al graphic design: come è diventato luogo comune il comandamento che proibisce di usare il Comic Sans per qualcosa che non sia appunto comico, così si stanno diffondendo i pochi precetti che bastano a creare un poster dignitoso. E se questi, insieme addirittura alle soluzioni di moda, vengono infine incorporati nei software e template di uso comune, come accade ad esempio con il generatore di Trendlist, la bomba potrebbe esplodere presto.
Quando attaccano i non professionisti, i grafici generalmente agitano lo spauracchio della qualità, sostenendo che il committente debba essere educato affinché la possa riconoscere. Forse è ancora lecito legare il concetto di qualità nel graphic design alle sue forme specializzate, penso al design dei caratteri, delle mappe o della segnaletica. O magari si può discutere di qualità con un certo grado di oggettività nel caso di progetti su larga scala, come l’identità di grandi musei o compagnie. Tornando però alla grafica diluita, vorrei concentrarmi brevemente su due casi che provano la debolezza di un approccio qualitativo. Entrambi includono a loro modo gli sviluppi da me descritti.

Paul Elliman, Avigail Moss (2007)
Nel 2007 Paul Elliman crea assieme ad Avigail Moss un impaginato pieno di Word Art, trattamenti tipografici disponibili su Word e generalmente abusati dai novizi. Oltre a fare un uso per così dire “affermativo” di uno strumento alla portata di tutti, Elliman e Moss riprendono la grafica vernacolare delle locandine affisse ai muri delle chiese. La scelta ha senso poiché la locandina promuove una performance che si tiene in una cattedrale. La voce, tema dell’evento magistralmente evocato dalla tipografia, rappresenta una delle ossessioni di Elliman, il quale è sia designer che scrittore. Come distinguere questo progetto dalle comuni locandine amatoriali? Non ci rimane che arrenderci al fatto che il context è king.

Ma la commistione di democratizzazione tecnologica, amatorialità e intellettualizzazione non coinvolge soltanto sparuti designer all’avanguardia. Lindsay Ballant propone un’analisi comparativa delle campagne di Hillary Clinton e Bernie Sanders. L’autrice sostiene che il sistema di comunicazione di Sanders, meno rigido e decisamente più incasinato (dal suo punto di vista più “autentico”) dell’impeccabile immagine coordinata sviluppata da Michael Bierut/Pentagram per la Clinton risulti paradossalmente più forte, poiché in grado di accogliere spinte differenti e addirittura contraddittorie, dunque in ultima analisi più “vere”.

Alla luce dei risultati, pare che Ballant abbia omesso il vero uragano comunicativo delle ultime elezioni, esponenzialmente più incasinato e autentico (se per questo intendiamo non calato dall’alto) di quello di Sanders. La “meme machine” di Trump sembra aver svolto un ruolo cruciale nella sua ascesa: i meme forgiati su 4chan e 8chan, poi “andati a morire” su reddit, ripresi dunque dagli account ufficiali del candidato, sono stati ricondivisi su scala globale e discussi sulle maggiori testate giornalistiche sotto l’etichetta dell’Alt-Right, e addirittura sui canali della stessa Clinton. L’amatorialità radicale dei sostenitori di Trump mescola riferimenti cinematografici, appropriazioni di comics, simboli del Terzo Reich. Il tutto utilizzando a volte software liberi come Gimp o semplici generatori online. Inoltre il culto esoterico che anima la produzione di questi meme ha un indubbio valore letterario e non è poi così distante da complesse religioni satiriche con tanto di testi sacri come il Discordianesimo.
Mi è capitato di mostrare la locandina in Word Art e qualche meme di Pepe a studenti da poco introdotti al mondo della grafica.
Tutti loro, col sorriso sulle labbra, hanno pensato che il mio fosse uno scherzo. Come biasimarli? Dopotutto sono stati esposti per mesi a un sottaciuto manicheismo secondo cui le semplici astrazioni del design sono il Bene, mentre il mondo, pubblico e committenza inclusi, è il Male. E come biasimare questa società malvagia che non riconosce il valore del graphic design? Chiaramente non parlo del design prodotto ad esempio presso Google, offerto gratuitamente a milioni di utenti. Parlo della coda lunga, popolata da progettisti costretti, per poter sopravvivere, a convincere il proprio cliente che il layout sviluppato apposta per il suo blog, artigianalmente, con poche risorse, sia migliore dell’interfaccia di, per dire, Medium, impeccabile piattaforma gratuita.

Per soppesare la percezione del valore economico attribuito dal pubblico alle opere di graphic design, basta riesumare la vicenda del logo del Madre, museo d’arte contemporanea di Napoli. Costo apparente del restyling: 20mila euro (briciole). Risultato: sommossa popolare sui social accompagnata da una pletora di parodie del logo portatrici di un evangelico messaggio: “lo potevo fare pure io”. Quest’anno, in seguito all’epic fail del Fertility Day, il ministro Lorenzin si è rivolta pubblicamente ai creativi, chiedendo loro di dare una mano a progettare la prossima campagna. A titolo gratuito, s’intende.
“Make the world a better place”
Se andassi a studiare graphic design a Yale, mi ritroverei tra i docenti Paul Elliman. Cosa mi insegnerebbe? Apriremmo insieme Word per cazzeggiare con i settaggi? Mi chiederebbe di scrivere un saggio di visual studies? Su quali basi è possibile fondare una didattica del graphic design, quando tutto ciò che lo riguarda appare relativo?
Invece di andare a Yale, ho fatto Disegno industriale al Politecnico di Bari, che non è certo noto per la sua eccellenza nel design. Ricordo uno dei primi giorni di università, quando un professore ordinario tutto sussiegoso proclamò senza la minima compassione che solo un paio di noi sarebbero effettivamente diventati dei designer. Ed è subito Highlander, la serie però, con il suo indimenticabile “ne rimarrà soltanto uno”.
Benché a differenza di altri dipartimenti, nell’ambito del design si lavori spesso in gruppo, la competizione fa parte del suo imprinting educativo. Un’attitudine che non solo coinvolge il rapporto con gli altri, ma anche quello con se stessi, dato che si è immersi in un mare di nottate, insonnia e abnegazione. Un atteggiamento che capitalizza sulla passione e sull’idea che il design non sia un lavoro bensì uno stile di vita. A un certo punto, tra i miei colleghi si era diffusa la pratica di includere nei ringraziamenti della propria tesi, oltre ad amici e parenti, anche il caffè, perché, come recita Coffee Company, “sleep is overrated”.

Sandberg Instituut (2016)
Una volta superati se stessi e gli altri, a cosa dedicare il proprio talento? Qualche giorno fa leggevo un’intervista a Ruben Pater, designer di spicco, il quale insegna presso alcune delle migliori scuole di design presenti in Olanda, una delle patrie del graphic design contemporaneo. Rispondendo a una domanda sul suo metodo didattico, Pater dichiara di “provare a incitare i designer a produrre dell’ottimo lavoro, e nel frattempo, a immaginare i bisogni e gli interessi del restante 99%”.
![]()
Questa spinta genera quello che è stato ribattezzato critical design, caratterizzato spesso da una curiosa situazione: aspiranti designer maturano l’urgenza di risolvere un problema che affligge qualche paese in via di sviluppo, mentre la sera o nel weekend fanno un “lavoro di merda” (bullshit job, termine tecnico coniato dall’antropologo David Graeber), magari in un call center. In pratica, mentre si concentrano sul restante 99%, dimenticano di farne parte essi stessi. Difficile non notare un’analogia con il mondo delle startup californiane, desiderose di “rendere il mondo un posto migliore”. E l’aspirante designer, che sia critical o meno, non è poi così diverso dallo startupper che lavora ininterrotamente nel suo scantinato per poi creare un prodotto rivoluzionario (magari riuscendoci, eh).
Inoltre startup tecnologiche e design sono entrambi affetti da ciò che Evgeny Morozov chiama soluzionismo, l’idea secondo cui per risolvere un problema sociale sia sufficiente una soluzione tecnica. E tale fiducia nella tecnologia e nella scienza mi pare alquanto dubbia quando espressa dal graphic design, pratica fondamentalmente umanistica le cui basi scientifiche appaiono assai confuse. Sarebbe forse meglio parlare di graphic design come linguaggio, evidenziandone in questo modo la componente ideologica.
Sia il designer nel call center che lo startupper nel garage sono vittime della dissonanza cognitiva di ciò che chiamo entreprecariato, ovvero la reciproca influenza tra la pressione imprenditoriale, che avviene innanzitutto a livello sociale, e una precarietà (materiale, professionale, esistenziale) sempre più diffusa. Il designer e lo startupper sembrano entrambi vivere al tempo stesso due vite parallele, entrambi sono soggetti divisi.
Una possibile via d’uscita per l’aspirante designer è proprio l’ambito educativo. Dato che le logiche di mercato raramente consentono di fare un design che sia critico, colto, intellettualmente appagante, si punta a diventare docenti, tutor, guest lecturer. Lo spazio protetto della scuola produce il contesto ideale per infinite discussioni su questioni sociali, accompagnate dall’immancabile workshop. Facendo riferimento ai master di scrittura creativa, Timothy Small parla di un grande schema Ponzi, “un processo per il quale uno scrittore senza soldi inizia ad insegnare ‘per arrotondare’, creando 15 scrittori senza soldi che inizieranno a loro volta ad insegnare ‘per arrotondare’ grazie alla raccomandazione del primo scrittore-insegnante, e che a loro volta produrranno altri 15 scrittori senza soldi, etc., etc.” Mi chiedo se il graphic design colto non segua la stessa logica. Nell’articolo, Small intervista un giovane scrittore di Brooklyn, divenuto a sua volta insegnante, il quale dichiara di aver scelto di fare un master per poter “comprare due anni di tempo per scrivere, […] due anni del tipo di vita che i ricchi hanno tutti gli anni, in cui i soldi non sarebbero stati un problema.”
Elite temporaneamente autonome
Al Politecnico di Bari, dove a malapena si poteva stampare un A4 in bianco e nero, la dichiarazione dell’altero professore non ci pareva convincente, quasi certi come eravamo che nessuno ce l’avrebbe fatta. Dato che la logica della competizione si era parzialmente inceppata, dovemmo accontentarci di un gioviale spirito di gruppo che coinvolgeva alcuni docenti e ci spingeva ad affrontare questioni locali (la mia tesi, prodotta in collaborazione con altri due colleghi, riguardava una caserma abbandonata nel cuore di Bari paragonabile, per estensione, al suo centro storico). Inutile dire che, potessi tornare indietro, non cambierei quel “modello educativo” per nulla al mondo. A distanza di anni designer lo siamo diventati in molti, ma non me la sento di dire che ce l’abbiamo fatta.
Fare design a Bari era come ascoltare in radio una fitta comunicazione che solo di tanto in tanto si riesce a captare. Credo che la marginalità geografica della mia università simboleggi adeguatamente l’attuale marginalità culturale e professionale del graphic designer. Propongo dunque che sia proprio la marginalità il punto di partenza per qualsiasi progetto didattico riguardante il graphic design. Tenendo tale premessa a mente, sarebbe più facile prendere atto della trasformazione del graphic design da lavoro creativo a lavoro cognitivo. Questa mutazione, che coinvolge molti altri settori dell’economia dei servizi, contiene in sè una tragica implicazione: la guerra contro il lavoro gratuito e la svalutazione del graphic design è stata persa. Magari si vincerà qualche specifica battaglia, ma in un contesto caratterizzato da un’incessante cascata di contenuti e strumenti gratuiti è sempre più difficile accettare di pagare anche una modica cifra per un bene immateriale.

MyCreativity, 2006
Che fare? Prima di tutto è necessario prendere coscienza del fatto che avere problemi economici come lavoratore cognitivo è un fatto strutturale, non individuale. Negli anni 2000 Richard Florida teorizzava l’avvento della “classe creativa” e ne elogiava il protenziale trasformativo. Pochi anni dopo il gruppo MyCreativity riformulava pragmaticamente il concetto parlando di autosfruttamento, precariato e sottoclasse creativa. Bisogna ammettere che le scuole di design contribuiscono a popolare questa sottoclasse creativa. Quindi mi pare sensato parlare di scuole di design come anticamere del precariato. Al tempo stesso però queste scuole si potrebbero definire, parafrasando Hakim Bey, delle elite temporaneamente autonome, dato che costituiscono uno spazio in cui è possibile acquistare, letteralmente, un certo controllo del proprio tempo.
Ma a quale scopo? Quello di organizzarsi. Se la gratuità è inarrestabile, forse è ora di estendere il bersaglio delle proprie critiche. Ovvio, il cliente che non paga resta uno sfruttatore, ma la questione va affrontata a un livello più ampio. Per questo credo che proposte radicali come il reddito di base universale, pur essendo magari non realizzabili nella pratica o addirittura controproducenti, sono tuttavia in grado di riformulare il discorso sul significato del lavoro. Per quale motivo il lavoro di una madre o una casalinga non viene considerato tale? La ragione è semplice: poiché non produce reddito, è gratuito. Che la lotta per il reddito debba affiancare quella contro la gratuità? Immagino una scuola di design che agisca come un think tank attivo nella ridefinizione del senso del lavoro e che contribuisca a sviluppare strategie per una nuova egemonia culturale.

Designers’ Inquiry (2012-13)
A pensarci bene, degli sforzi in questo senso sono stati già compiuti, proprio qui in Italia. I Brave New Alps, duo di graphic designer che militano nel cuore delle alpi trentine, da anni catalizzano il dibattito sulle condizioni lavorative dei designer. Nel 2013 hanno prodotto assieme al Cantiere per pratiche non affermative un’inchiesta, unica nel suo genere, che prova a mappare il profilo economico e sociale di chi si identifica come “designer”. La Designers’ Inquiry è stata lanciata non a caso durante il Salone del mobile, epitome del design imprenditoriale ricco, opulento e sfavillante. I Brave non si sono fermati qui e, assieme a Caterina Giuliani, hanno messo in piedi il Precarity Pilot, piattaforma fisica e virtuale che include una serie di “buone pratiche” per organizzare la propria carriera, ridefinire la nozione di successo, attivare dinamiche di cooperazione, e via dicendo. Chissà che non sia proprio questa la strada, quella politica, attraverso cui riaffermare il ruolo intellettuale del designer e, visto che ci siamo, del cognitariato in generale.
Elaborazione di una lezione tenuta alla Scuola Open Source di Bari


