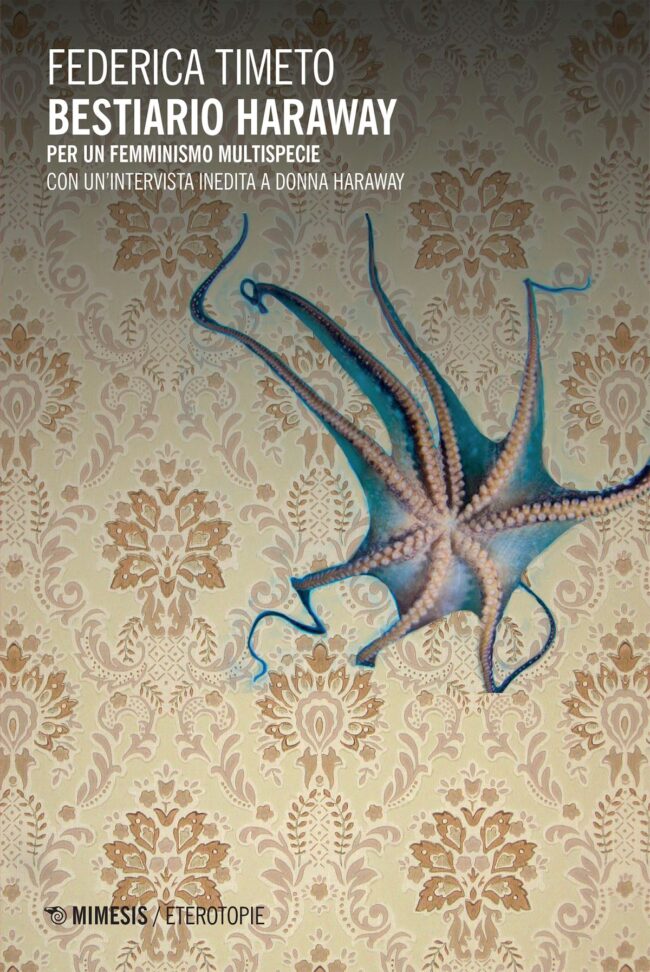Gli animali non umani sono stati usati come specchi per riflettere l’umanità dell’umano e sancirne il distacco dall’animalità. Il modo in cui abbiamo lucidato questi specchi, come scrivi già in Animal Sociology (1978), è dipeso molto da ciò che volevamo apparisse, e dalle strategie rappresentazionali che abbiamo messo in atto. In Otherworldly Conversations; Terrain Topics; Local Terms (2008) sostieni, però, che “il punto non sono nuove rappresentazioni, quanto piuttosto nuove pratiche”. Puoi spiegare meglio il senso di questa affermazione?
Prima di tutto cercherei di capire dove ci troviamo oggi, in quale tempo e spazio.
Stiamo assistendo alla terribile devastazione degli incendi in Australia. Per quanto mi riguarda, ho già fatto esperienza degli incendi in California, e temo che la farò di nuovo, e abbiamo visto gli incendi in Siberia, e molte alte catastrofi che coinvolgono gli esseri umani e più che umani, gli animali, le piante, i funghi e molte altre forme di vita, catastrofi straordinarie che causano estinzioni e che sono paragonabili a genocidi, il risultato di decenni, anzi secoli di avidità.
Ci sono certamente eventi non attribuibili all’azione dell’uomo, ma questi nello specifico sono causati, non direi dagli esseri umani in generale, ma da un sistema, un ordine di persone che, volendo usare una sola parola, potremmo riassumere nel termine “capitalismo”: cinquecento anni di capitalismo coloniale, le sue politiche estrattive e predatorie, la distribuzione diseguale delle risorse e la creazione di ricchezza attraverso pratiche tremendamente ingiuste. Penso che oggi ognuno di noi sia in lutto per la perdita di molteplici forme di vita fra loro connesse, umane e più che umane.
Se consideriamo le rappresentazioni mediali degli incendi, appare evidente che ci sono delle specie “carismatiche”, per esempio il koala, che ricevono una notevole dose di attenzione, e questo è senza dubbio ottimo, perché le pratiche rappresentazionali possono anche mirare a coinvolgere emotivamente, e si tratta di animali già molto conosciuti. Ma il punto è che queste pratiche non arrivano a connettersi davvero in profondità con gli interrogativi degli aborigeni australiani sui regimi degli incendi, né con la prospettiva dei colonizzatori su questi regimi, non si collegano profondamente alle pratiche degli scienziati, degli ecologisti o degli indigeni che cercano di resistere, e finiscono per mettere in evidenza solo un animale iconico che soffre. Non che siano rappresentazioni dannose, è che non avviano una riflessione sulla profondità del lutto e sulle azioni che dovremmo mettere in atto. […]
La difesa dei diritti degli animali, al centro delle battaglie di molti animalisti, presenta diversi aspetti problematici, tra questi il fatto che resta ancorata a una prospettiva sostanzialmente antropocentrica, privilegia gli aspetti morali spesso a scapito delle analisi politiche a più ampio raggio, e, come anche tu sottolinei, preclude la considerazione di verità parziali e anche scomode dietro il mantra del giusto e dell’ingiusto.
Non credo che rifiutarsi di usare queste categorie sia la strategia più corretta, anche se io e chi ha lavorato a fianco a me, le persone con cui ho stretto alleanze e condiviso diverse battaglie, siamo sempre stati molto critici in proposito, ma allo stesso tempo continuiamo a lavorare all’interno di queste categorie per fare quello che si può e va fatto.
Per esempio, l’attacco alle specie a rischio in USA sotto il regime di Trump deve assolutamente essere contrastato, e l’unico modo per farlo è impegnarsi in una politica che rafforzi le leggi a difesa delle specie in pericolo.
L’attacco alle specie a rischio in USA sotto il regime di Trump deve assolutamente essere contrastato
Dunque, sono certamente critica rispetto all’uso della categoria dei diritti quando questo approccio impedisce di avere una visione più approfondita delle storie, delle responsabilità, delle connessioni fra le cose, e tuttavia sono categorie importanti di cui non possiamo disfarci dall’oggi al domani.
Certo, se poi pensiamo che nei possedimenti dei colonizzatori bianchi, come le terre dell’Australia e degli Stati Uniti, la legge garantisce l’esproprio dei nativi e il rafforzamento di strutture sociali colonialiste e razziste, appare evidente che la legge è parte di un dispositivo che garantisce l’esercizio dell’egemonia bianca, e in una cornice capitalista e colonialista non serve solo a questo ma supporta anche lo sviluppo della contemporanea – per modo di dire, visto che parliamo di qualche centinaio di anni! – strutturazione in classi, e poi la misoginia, per non dire del disprezzo per tutto ciò che non è propriamente “umanista”… Tutto questo è scritto nella forma della legge. […]
Quali pratiche e processi possiamo mettere in atto per giungere ad altre forme di organizzazione e relazione, e con chi possiamo allearci in questi momenti problematici, chi sono i nostri alleati? Per quel che riguarda me, nel mio specifico posizionamento, come figlia del colonizzatore bianco, ma possiamo anche far ricorso a un “noi” più generico, credo che dovremmo allearci con le lotte di gruppi come Black Lives Matter, Idle No More, Leave It In The Ground, coloro che difendono le acque locali o i movimenti che combattono perché sia fatta chiarezza sulla sparizione delle donne indigene…
A questo proposito, qual è la tua opinione sulla protesta dei Fridays for Future?
Beh, perché no. Non credo sia un movimento rivoluzionario o supertrasformativo, ma è certamente un fenomeno positivo. Porta la gente in piazza, gli scioperi nelle scuole (e fa arrabbiare i docenti che non li appoggiano), anche se per esempio, nel movimento, non è adeguatamente messo in rilievo il ruolo che i/le giovani leader non bianchi/e hanno nelle lotte per la giustizia e il benessere ambientale in senso lato.
Le donne delle comunità native in Alaska hanno manifestato per far luce sulle sparizioni delle compagne indigene
Ammiro senz’altro Greta Thunberg, ma è anche vero che i media si focalizzano sempre su quello che è più facile riportare e non, per dire, sulle donne e le ragazze delle comunità native che in Alaska, in queste ultime settimane, hanno manifestato facendo cerchi coi tamburi e proteste simili per far luce sulle sparizioni delle compagne indigene e comprendere le conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai causato dall’innalzamento delle temperature.
È davvero difficile sentir parlare di queste cose nell’ambiente mediale dominante. È chiaro che sono favorevole ai FfF, e tuttavia bisogna anche saper cercare le informazioni con attenzione, attraverso canali non ufficiali. […]
Le nostre pratiche dipendono sempre molto dalle rappresentazioni con cui ci confrontiamo…
Anche questo ha molto a che fare con la rappresentazione degli animali, sicuramente: nuovi modi di rappresentare gli animali significa adottare nuove pratiche, le due cose non sono separabili.
Supporto al massimo chi cerca di formulare nuove pratiche di rappresentazione, ma mi interessano soprattutto le pratiche di engagement, non limitate agli attori sociali solo umani. Cercare di capire a cosa sono interessati gli altri organismi, come vivono le loro vite, non solo come noi ci intromettiamo in esse, per diventare capaci di praticare quello che Jacob Metcalf, un amico ed ex studente, ora un giovane filosofo, ha definito “intimità senza vicinanza” [intimacy without proximity].
Come conoscere con cautela ed entrare in relazione senza per forza essere al centro dell’azione: non devi essere sempre fisicamente coinvolto, non devi sempre intervenire, insomma imparare a conoscere gli altri esseri che abitano il mondo senza porre se stessi al centro, sperimentando sul campo, o scrivendone, ma per farlo bisogna essere davvero in grado di coltivare altre capacità che oltrepassano il linguaggio in senso umano.
Mi interessano soprattutto le pratiche di engagement
Come nell’approccio femminista alla giustizia ambientalista, per esempio: le capacità di toccare, odorare, ascoltare, comprendere che “sentire” non è solo sentire umanamente, che le parole non sono solo quelle del linguaggio verbale.
Penso a Jacob von Uexküll e alla sua idea di Umwelt: coltivare la capacità di capire come altri esseri nel mondo costruiscono il loro ambiente per entrare in relazioni di proliferazione condivisa [co-flourishing]. […]
In un’intervista hai sostenuto che le ecologie sono sempre, almeno, tripartite: umani, creature altre dagli umani, e tecnologie. Questa triade è anche al cuore della figurazione cyborg, sebbene generalmente si discuta piuttosto delle conseguenze liberatorie dell’ibridazione tra umano e macchinico, escludendo dall’analisi la considerazione degli animali non umani. Esiste un modo per immaginare un potenziale trasformativo anche nell’incontro tra viventi non umani e tecnologie, che non veda gli animali solo come strumenti, ma che parta dal loro essere senzienti e resistenti? Se pensiamo al complesso animal-industriale, agli esperimenti in laboratorio, alla robotica applicata agli allevamenti intensivi, non è facile immaginare una cosa simile…
Da molto tempo io stessa non uso più questa figurazione. Perché mi sono piuttosto interessata ad altri modi per abitare le figurazioni, come quella contenuta nella nozione di “specie compagne”.
Non che il cyborg non funzioni più, ma credo che vada messo in relazione a una cucciolata di altre creature, mentre troppo spesso lo si è considerato isolatamente.
D’altra parte, non ho mai pensato che le figurazioni o le realtà cyborg in sé siano qualcosa di necessariamente opposto agli animali, alle piante, ai funghi o ai batteri, perché fin dall’inizio per me riguardavano i viventi umani, non umani, le tecnologie e le forme di differenziazione di altri sistemi naturalculturali.
È triste, ma innegabile, vedere che l’incontro con gli animali non umani e le macchine avvenga oggi in modi che vedono gli animali perlopiù collocati in una posizione strumentale, ma non sono convinta che questa sia tutta la storia, perché ci sono alcune importanti tecnologie che favoriscono positivamente gli “animali” – e stiamo usando questo termine per motivi di comodo, perché è più facile, ma il problema è anche questo! Bisogna ovviamente estendere il discorso a una più ampia categoria di viventi.
Non che il cyborg non funzioni più, ma credo che vada messo in relazione a una cucciolata di altre creature
Consideriamo per un momento le creazioni di mondi cyborg che includono esseri umani, animali e tecnologie che potremmo condividere: per esempio molte ricerche nel campo della medicina veterinaria, la questione dei vaccini e l’immunologia, gli interessantissimi lavori della medicina del comportamento, che riguardano sia gli animali selvatici sia gli animali con cui conviviamo nelle nostre case.
Penso agli studi sulla salute ambientale che si servono di ricerche come quelle, per esempio, in cui si esaminano in laboratorio, tramite strumentazioni digitali super-sofisticate, le feci delle scimmie che vivono sugli alberi, e se ne analizza l’olobioma per comprenderne le abitudini alimentari, e in che pattern naturalculturali questi animali vivono.
Potremmo chiamare mondeggiare cyborg la formazione di quegli apparati che si compongono di macchine di vario tipo, dalle più tradizionali alle più nuove, e che coinvolgono piante, microbi, animali, esseri umani, residenti e semplici visitatori, aiutandoci a capire meglio un mondo che tutti vorremmo più rigoglioso.
A conti fatti, non concordo con l’idea che l’incontro fra animali e macchine sia sempre nocivo per gli animali, anzi penso che dovremmo dare più forza a queste pratiche, pubblicizzarle, scriverne, divulgarle. […]
In occasione del panel che hai organizzato con Adele Clarke alla conferenza della Society for Social Studies of Science a Denver (Novembre 2015) intitolato Generate parentele, non bambini [Make Kin Not Babies], poi in Chthulucene, e ancora nel testo inserito nell’antologia che hai curato con la stessa Clarke, Making Kin in the Chthulucene: Reproducing Multispecies Justice, usi il termine “oddkin” per parlare della creazione di legami di parentela non riproduttiva e alleanze trasversali e responsabili. Come spiegheresti questa parola così difficile da tradurre?
“Odd” non vuol dire propriamente “strano”, ma è qualcosa che non quadra [doesn’t fit], fuori categoria, come dire, per esempio, lei è mia sorella, ma non è la figlia di mia madre né di mio padre, e non perché sia adottata, ma perché è una sorella di un’altra specie, ma forse anche sorella è una parola sbagliata, avremmo bisogno di un diverso vocabolario delle parentele: formiamo parentele di continuo, e nel momento in cui lo facciamo in modi creativi e generativi, le categorie esistenti, ovviamente, non si adattano più tanto bene.
Insomma un’espressione queer…
È vero, io parlo deliberatamente di queer, per quanto credo che questo termine non possa essere usato genericamente, per definire qualsiasi cosa, ma necessiti sempre di essere adattato al suo funzionamento specifico, anche perché altrimenti sarebbe irrispettoso, fra le altre cose, per la comunità LGBTQI.
La parola queer ha un certo numero di confini che a volte la delimitano e a volte sono aperti, addirittura spalancati… i confini sono luoghi molto interessanti per quel che vi succede intorno, l’aprirsi, il chiudersi, il contrarsi dei confini…
Dunque, generare parentele inappropriate, fare oddkin, è il lavoro in cui dovremmo impegnarci, stringere legami di parentela non necessariamente umani o anche legami fra umani con persone con cui non siamo ancora in connessione.
Generare parentele inappropriate, fare oddkin, è il lavoro in cui dovremmo impegnarci
Generare parentele non indica una forma di relazione qualsiasi, ma una relazione che comporta delle conseguenze: se ho un cugino, un cugino ha me, per dire, e non solo per cinque minuti, si tratta di una promessa che si estende per generazioni, una promessa di fare generazione insieme, mondeggiare per quello che deve ancora venire.
Non significa, insomma, stringere semplicemente delle amicizie, avere amici è bello ma non tutti gli amici sono parenti: diventare parenti è una promessa molto più grande, contiene la reciprocità e il tempo dentro di sé, implica la promessa di prendersi cura delle generazioni che verranno, non solo dell’adesso.
Generare parentele è una cosa seria: se ho un cane e un cane ha me, è per la vita intera, non importa i problemi che potranno sorgere, che potranno anche essere estremamente gravi al punto che uccidere il cane potrebbe apparire l’unica cosa giusta da fare a un certo punto.
Generare parentele significa assumersi la responsabilità di tutto quello che la complessità del vivere e morire condiviso comporta, nutrire e saper uccidere allo stesso tempo. Generare parentele non è per nulla una pratica tenera e delicata … certo, c’è tanto amore, affetto, gioia, ma in sostanza si tratta di prendersi cura delle generazioni. […]
Perchè ritieni che parlare di Chthulucene piuttosto che di Antropocene sia più adeguato ad affrontare quello che accade adesso e restare coi piedi ben piantati nel trouble?
Non sono una persona che si disfa delle parole, piuttosto mi piace moltiplicarle, dunque aggiungo Chthulucene alla lista piuttosto che cancellare con questo termine quelli di Antropocene o Capitalocene.
E uso molto consapevolmente anche la parola Piantagiocene, che accolgo dagli studiosi afroamericani e dalla considerazione della centralità della storia delle piantagioni e della schiavitù.
Senza generalizzare, aggiungo Chthulucene al mix per riportare l’attenzione sulla dimensione ctonia, terrena. Non si tratta di qualcosa di morto, di un tempo antico ormai trascorso, si tratta dell’adesso, gli esseri terreni sono viventi, e noi siamo terreni piuttosto che “a termine”. Il tempo degli esseri terreni è l’adesso, ed è per questo che preferisco complicare il quadro, perché ritengo urgente pensare insieme agli esseri multipli della terra, e includerci in questo insieme, coinvolti nelle pratiche dinamiche del fare mondi.
Adesso, perché non c’è un tempo dell’origine e poi la decadenza, c’è l’adesso. È un modo per impegnarsi nelle pratiche rappresentazionali e politiche dell’Antropocene e del Capitalocene con una connessione più profonda con la terra.
[Questa conversazione è avvenuta via Skype il 3 Gennaio 2020]
L’intervista è un estratto dal volume Bestiario Haraway (Mimesis) di Federica Timeto