François Jullien, pensare l’efficacia: dai supereroi agli strateghi cinesi
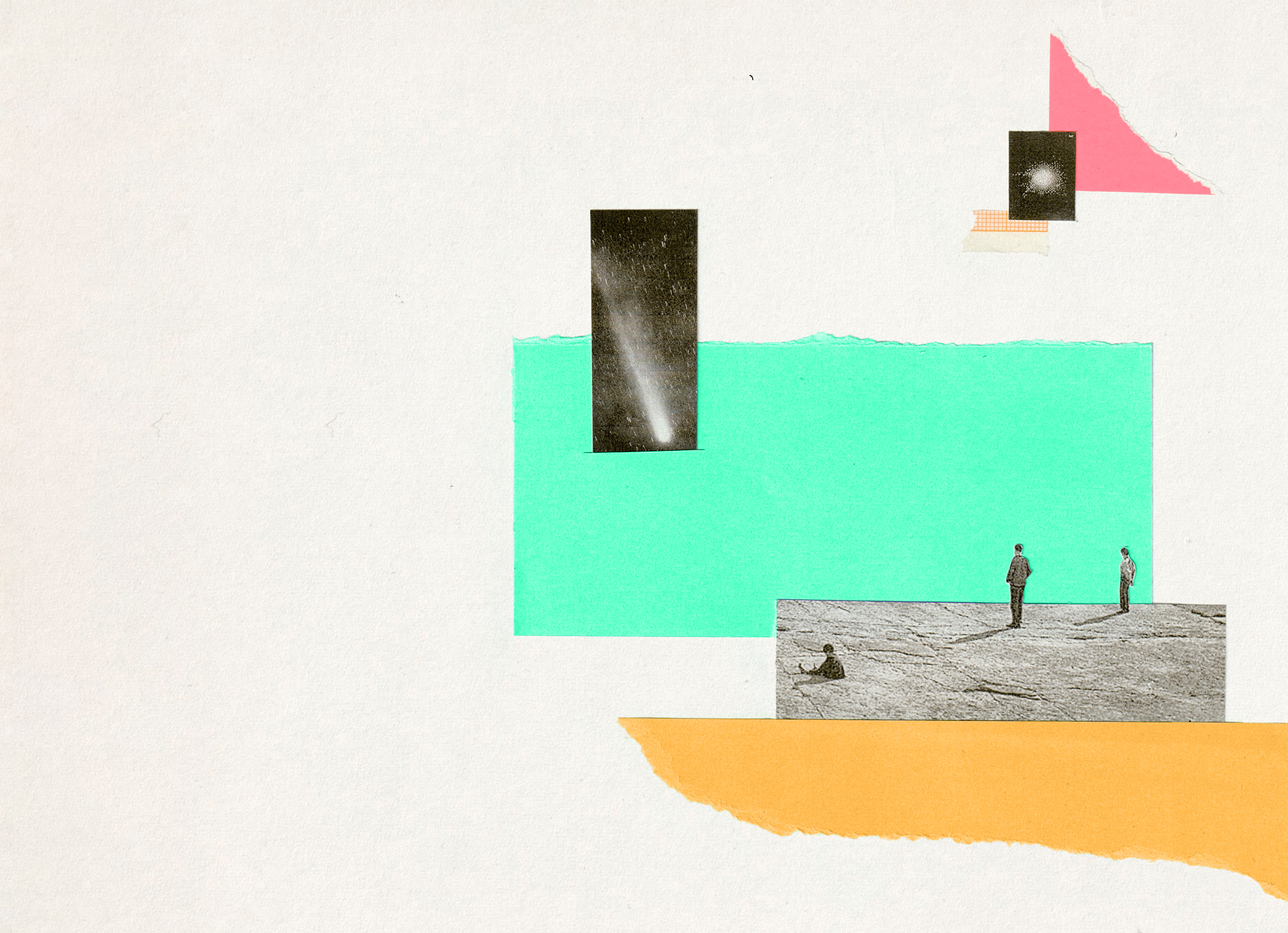
Nella nostra cultura, il successo è fatto da eroi. Un generale, uno scienziato, un rivoluzionario o un imprenditore di successo, qualche fuorilegge dei western, un supereroe dei fumetti o un protagonista di serie TV… In questo universo ideale salvare il mondo, la principessa, oppure affermare la verità, la giustizia o anche solo se stessi è questione di slancio, di sacrificio e di abnegazione. Potere e responsabilità. E un modello di pensiero tutto incentrato sull’Io: su cosa io posso o non posso fare, da quanto forte desidero qualcosa e da quanto mi impegno per ottenerlo.
Non è in questione l’egoismo o il suo contrario. Si tratta piuttosto di mettere a fuoco, più in profondità, un modello che è la base del modo stesso in cui concepiamo un’azione, a prescindere dal suo indirizzo. Della griglia concettuale che usiamo per leggere il nostro stare al mondo e interagire con esso. È uno schema di pensiero che nasce ben prima dei fumetti: si può far risalire ai primordi del pensiero occidentale, all’epica e alla filosofia greca. Da Aristotele a Machiavelli, il pensiero occidentale ha sviluppato una teoria dell’azione come gesto (per lo più eroico) per il raggiungimento di uno scopo. Per questo l’efficacia si è definita di conseguenza come la risultante del rapporto tra mezzi impiegati e fini perseguiti. Dove è il fine che orienta e giustifica l’azione.
Ebbene, questa forma mentis potrebbe non essere la più utile per affrontare le situazioni in maniera efficace. E di certo non è l’unica.
Un autore in particolare ha insistito molto sulla proposta di una mentalità alternativa a quella occidentale in tema di efficacia. Si tratta di François Jullien, sinologo e filosofo francese tra i più noti (e discussi) in Europa. Partendo dallo studio in parallelo dei classici del pensiero greco e cinese, Jullien si è concentrato sulla comparazione tra i modelli, con l’obiettivo non solo di presentare agli occidentali in pensiero cinese in forma divulgativa, ma anche di sviluppare senso critico rispetto ai molti preconcetti della nostra cultura di riferimento e del nostro sistema di valori. Anche se il rigore del suo metodo filologico e teorico è stato oggetto di discussioni tra gli specialisti, il grande valore del lavoro di Jullien esula dalla (peraltro sana) dialettica storico-accademica, ma si identifica proprio con questa grande capacità di rimettere in discussione del nostro modo di vedere (il mondo e noi stessi).
È il lavoro contenuto nei saggi La propension des choses (Seuil, Paris 1992) e Trattato dell’efficacia (Einaudi, Torino 1998), riassunto in modo magistrale in Pensare l’efficacia in Cina e in Occidente, uscito da Laterza nel 2006 nella bella traduzione di Massimiliano Guareschi
Parola chiave “efficacia”, dunque. Nella tradizione occidentale, come abbiamo detto, viene definita come la capacità di trovare il mezzo più economico, più rapido, più produttivo per perseguire uno scopo. Jullien ci ricorda che questa concezione è strettamente connessa con lo sviluppo nel pensiero occidentale del concetto di “forma ideale” (idea pura, categoria ecc.). Infatti, se l’obiettivo è un’anticipazione desiderata rispetto alla situazione che si vive, senza il livello dell’idealità nessun obiettivo è possibile.
In Cina l’idea di obiettivo non esiste, almeno non nel pensiero strategico: «Il cinese medio non possiede neanche un termine chiaro e preciso per indicarlo» (cfr. p. 36). L’assenza dell’idea di finalità una delle principali cause dello spaesamento che il pensiero cinese provoca in una mente occidentale. Jullien lo riassume con l’efficace formula di «prosciugamento dei fini» (p. 36). Dimentichiamoci quindi del telos e del suo ruolo essenziale nella metafisica e nella cultura occidentale, fin dall’inizio dei tempi.
Ma allora come fanno i cinesi ad agire nel mondo, a non soccombere agli eventi? La risposta sta in formula molto nota di Sun Tzu: «Le truppe vittoriose sono quelle che accettano il combattimento solo quando hanno già vinto; le truppe vinte sono quelle che cercano la vittoria soltanto nel combattimento».
Tutto si decide a monte. Il cambio di prospettiva ci porta a pensare la situazione come un insieme di condizioni, cioè di stati di cose determinati dal contesto, che possono essere favorevoli oppure sfavorevoli rispetto alla nostra azione. È così che si definisce il potenziale della situazione o, come scrive Jullien, la sua «propensione», che poi altro non è che una tendenza degli eventi a evolvere nell’una o nell’altra direzione.
Così, il pensiero cinese ammonisce chi si trova ad agire sugli eventi per affermare il proprio progetto o punto di vista di evitare di “forzare” la situazione pretendendo di modificare un groviglio di rapporti di forza sempre più forti di lui, ma lo invita piuttosto a cominciare con l’analisi della situazione e dalla conseguente determinazione degli aspetti positivi e negativi della stessa. E soprattutto, ad agire non per affermare se stesso, ma per facilitare, catalizzare, promuovere tutti quegli elementi che in una situazione sono favorevoli, o se non altro di contrastare quelli che sono sfavorevoli. Finché la situazione non muterà da sola e assumerà un nuovo equilibrio più positivo per noi.
Il vero vincente, nel pensiero cinese, non è l’eroe che in spregio del pericolo e a rischio della morte si impone nel confronto diretto con gli avversari, ma lo stratega che non va alla battaglia finché non ha determinato tutte le potenzialità della situazione ed è in grado di garantire che saranno gli stessi eventi a presentargli la vittoria. Che lui dovrà solo cogliere matura.
Perciò, un grande stratega è uno scienziato delle condizioni, che in una situazione determina le tendenze a lui favorevoli e quelle contrarie per poi agire non direttamente sul problema (o avversario), ma sulle tendenze della situazione. Finché il problema non si presenterà già risolto al suo cospetto (o l’avversario sconfitto).
Per questo la regola fondamentale della strategia cinese è combattere solo se si è sicuri di vincere, e sottrarsi allo scontro diretto se non lo si è. Ecco il senso cinese dell’efficacia.
Questo modello cinese dell’efficacia ha riverberi significativi in tutti i campi dell’agentività, dall’economia alla politica. Però, soprattutto, ci aiuta ad affermare una concezione delle situazioni non più incentrata sui voleri e le forze del singolo individuo, ma si fonda sull’analisi dei rapporti di forza, delle differenze di potenziale e dei contesti in cui i soggetti e le azioni sono di volta in volta collocate.
Un’applicazione pratica: la lunga marcia
Se ci si chiede in che modo si possa mettere in pratica questa filosofia, c’è un noto passaggio della storia cinese più recente che ce ne dimostra l’efficacia. Il protagonista è nientemeno che Mao Tse Tung, e il periodo è quello che intercorre tra il 1927, anno della repressione delle rivolte comuniste nelle città della Cina e dell’inizio della guerra ai comunisti da parte dei nazionalisti del Kuomintang, e il 1949, anno della definitiva presa del potere dei comunisti in Cina.
Alla fine degli anni ’30 il partito di Mao Tse Tung stava rischiando l’estinzione: i nazionalisti avevano stroncato le rivolte cittadine e imposto il loro ferreo dominio militare sul territorio con una serie di offensive (chiamate “accerchiamenti”) che avevano fatto cedere uno dopo l’altro i soviet costituiti nelle campagne.
Nel frattempo il paese era occupato anche dai giapponesi, avversari di entrambi gli schieramenti cinesi. Impossibilitati a resistere all’avanzata nazionalista contro il soviet della regione dello Jiangxi (nel sud-est, a ovest del fiume azzurro) i comandanti comunisti decidono di intraprende una lunga ritirata per sopravvivere: è la famosa “lunga marcia”.
Il genio di Mao Tse Tung sta nell’aver trasformato quella ritirata in una manovra per prendere il potere e battere il suo avversario. Da un lato, Mao ha deviato l’obiettivo della Lunga marcia verso l’attacco alle posizioni giapponesi, con una scelta che ha di fatto squilibrato i rapporti di forza tra i tre poli del conflitto. Ma, soprattutto, la lunga marcia gli ha permesso di prendere tempo rispetto alla situazione, di garantirsi la sopravvivenza del suo esercito in attesa che le condizioni mutassero (ovvero che il controllo del territorio da parte del Kuomintang cominciasse a indebolirsi a causa dell’avanzata giapponese) per poi sferrare il colpo finale quando l’avversario nazionalista era già di fatto sconfitto, sia sul fronte delle rivendicazioni nazionali (perché i comunisti avevano attaccato innanzitutto i giapponesi), sia su quello dello scontro politico (perché la stessa vittoria sui giapponesi dava ai comunisti nuovo lustro).
Rifuggendo lo scontro diretto con i Chiang Kai Shek e scegliendo di agire invece sulle condizioni sfavorevoli ai nazionalisti (ossia sui giapponesi), Mao Tse Tung ha interpretato e catalizzato il potenziale della situazione e si è garantito, con il tempo, il controllo del Paese.
La cosa più interessante è che il Kuomintang ha reagito alla sconfitta allo stesso modo, esiliandosi sull’isola di Taiwan e scegliendo di aspettare il momento più opportuno per ribaltare di nuovo la situazione a suo favore. La storia contemporanea della Cina fornirà gli elementi per valutare l’efficacia di questa mossa.
Il punto essenziale, però, è che l’azione efficace è stata quella di chi si è ritirato, ha temporeggiato e ha poi scelto di attaccare il nodo dei rapporti di forza a partire dai suoi gangli periferici, senza cercare uno scontro diretto a vocazione suicida.
Un modello per ripensare l’azione nel suo contesto
Al di là degli esempi storici in campo militare, il modello cinese messo a fuoco da Jullien è ricco di suggestioni anche sul piano culturale più generale. Perché non metterlo in campo, ad esempio, quando si ragiona sul rapporto tra tecnologia e conoscenza? Tra innovazione e tradizione? Tra trasformazioni del mondo del lavoro e richieste di sostenibilità e di garanzie fondamentali per i lavoratori? Ma non è forse utile applicarlo anche soltanto nei normali conflitti della nostra esistenza personale?
A partire dal duplice precetto di attendere le condizioni favorevoli e di agire non direttamente sul problema ma sul suo contesto (proprio per incentivare queste condizioni favorevoli) è possibile sviluppare un modello di azione nei contesti sociali e culturali che eviti le contrapposizioni sterili e sviluppi le trasformazioni positive senza provocare strappi o cesure con il contesto di riferimento. La forza del modello c’è, resta da sperimentarlo nella pratica.
Immagine di copertina: collage di Enea Brigatti